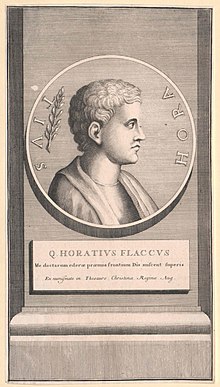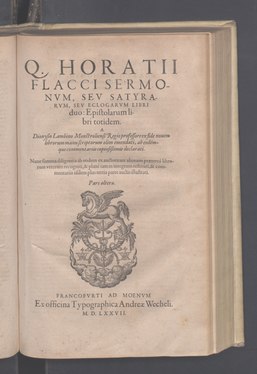«Mentre parliamo, il tempo invidioso sarà già fuggito: Assapora ogni istante, confidando il meno possibile nel domani.» (Orazio, Odi, I, 11, 7-8)
GRANDI PERSONAGGI STORICI Ritengo che ripercorrere le vite dei maggiori personaggi della storia del pianeta, analizzando le loro virtù e i loro difetti, le loro vittorie e le loro sconfitte, i loro obiettivi, il rapporto con i più stretti collaboratori, la loro autorevolezza o empatia, possa essere un buon viatico per un imprenditore come per una qualsiasi persona. In questa sottosezione figurano i più grandi poeti, pensatori e letterati che ci hanno donato momenti di grande felicità ed emozioni. Io associo a questi grandi personaggi una nuova stella che nasce nell'universo.
GRECI E LATINI
Alceo -
Anacreonte -
Anassagora - Anassimandro -
Anassimene -
Archiloco -
Aristofane -
Aristotele -
Callimaco -
Catullo -
Cicerone -
Democrito -
Diogene -
Empledoche -
Epicuro -
Eraclito -
Erodoto-
Eschilo -
Esiodo -
Euclide -
Euripide -
Livio -
Lucrezio - Marziale - Orazio -
Ovidio -
Pindaro -
Pitagora -
Platone -
Plinio Sr. -
Plinio Jr. -
Plutarco -
Saffo -
Seneca -
Socrate -
Solone - Svetonio -
Tacito -
Talete -
Tucidide -
Virgilio -
Zenone -
Quinto Orazio Flacco, noto più semplicemente come Orazio (Venosa, 8 dicembre 65 a.C. – Roma, 27 novembre 8 a.C.), è stato uno dei massimi poeti latini.

Statua di Orazio a Venosa, opera di Achille D'Orsi (1898)
Orazio nacque l'8 dicembre del 65 a.C. a Venosa, colonia romana fondata in posizione strategica tra Apulia e Lucania, allora in territorio dauno e attualmente in Basilicata. Fu figlio di un fattore liberto che si trasferì poi a Roma per fare l'esattore delle aste pubbliche (coactor auctionarius), compito poco stimato, ma redditizio; il poeta era dunque di umili origini, ma di buona condizione economica.
Recepì le prime nozioni di favolistica dalla nutrice Pullia, che amava raccontare le fiabe. Dopo aver trascorso la fanciullezza nella terra natia, Orazio seguì un regolare corso di studi a Roma, sotto l'insegnamento del grammatico Orbilio e poi ad Atene, all'età di circa vent'anni, dove studiò greco e filosofia presso Cratippo di Pergamo. Qui entrò in contatto con la lezione epicurea, ma, sebbene se ne sentisse particolarmente attratto, decise di non aderire alla scuola. Sarà all'interno dell'ambiente romano che Orazio aderirà alla corrente, la quale gli permise di trovare un rifugio nell'otium contemplativo. Il poeta espresse la sua gratitudine verso il padre in un tributo nelle Satire (I, 6).
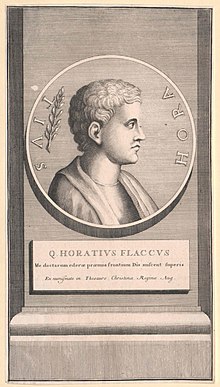
Orazio in un'incisione settecentesca.
Dopo la morte di Cesare, quando scoppiò la guerra civile, Orazio si arruolò nell'esercito di Bruto, nel quale il poeta incarnò il proprio ideale di libertà in antitesi alla tirannide imperante. Combatté come tribuno militare nell'esercito repubblicano comandato da Bruto nella battaglia di Filippi (42 a.C.), persa dai sostenitori di Bruto e vinta da Marco Antonio e Ottaviano. In questa battaglia Bruto e Cassio perirono, mentre Orazio si diede alla fuga dopo il secondo combattimento, come confessa egli stesso in una delle sue odi, nella quale dice che si era di già trovato in alcune altre azioni molto pericolose.
Nel 41 a.C. tornò in Italia grazie a un'amnistia e, appresa la notizia della confisca del podere paterno, si mantenne divenendo segretario di un questore (scriba quaestorius). In questo periodo cominciò a scrivere versi, che cominciarono a dargli una certa notorietà.
Nel 38 a.C. venne presentato a Mecenate da Virgilio e Vario, probabilmente incontrati nel contesto delle scuole epicuree di Sirone, presso Napoli ed Ercolano. Dopo nove mesi Mecenate lo ammise nel suo circolo e da allora il poeta poté dedicarsi interamente alla letteratura, non si sposò mai e non ebbe figli. Già in questo periodo Orazio risulta debole di occhi, avendo contratto una congiuntivite.
Mecenate gli donò nel 33 a.C. un piccolo possedimento in Sabina, le cui rovine sono ancor oggi visitabili nei pressi di Licenza (RM). Il dono fu cosa molto gradita al poeta che, in perfetta osservanza del modus vivendi predicato da Epicuro, non amava la vita cittadina.
Con la sua poesia Orazio sostenne la figura e la politica dell'imperatore Augusto, che peraltro in questo periodo lasciava una grande libertà compositiva ai suoi poeti (tendenza che sarebbe però stata invertita dopo la scomparsa di Mecenate: lo testimonia la vicenda biografica di Ovidio). Esempi di propaganda augustea sono, a ogni modo, alcune Odi e il Carmen saeculare, composto nel 17 a.C. in occasione della ricorrenza dei Ludi Saeculares.
Orazio morì il 27 novembre dell'8 a.C. e fu sepolto sul colle Esquilino, accanto al suo amico Mecenate, morto solo due mesi prima.

Placca a Taranto che reca inciso il verso di un'ode che Orazio dedicò alla città
Considerato uno dei maggiori poeti dell'età antica, nonché maestro di eleganza stilistica e dotato di inusuale ironia, seppe affrontare le vicissitudini politiche e civili del suo tempo da placido epicureo amante dei piaceri della vita, dettando quelli che per molti sono ancora i canoni dell'ars vivendi.
«Mentre parliamo, il tempo invidioso sarà già fuggito:
Assapora ogni istante, confidando il meno possibile nel domani.»
(Orazio, Odi, I, 11, 7-8)
«Almo Sole [...] che tu possa contemplare nulla di più grande della città di Roma.»
(Orazio, Carmen saeculare.)
Si può riconoscere in molte delle occasioni, da cui Orazio trae spunto per i suoi componimenti, una funzione comunicativa: ma difficilmente essa si traduce in un mero fine encomiastico, nei confronti del circolo dei suoi potenti protettori, perché assai più spesso essa svolge la funzione di trasmettere al lettore (e ai posteri) un'esperienza concreta di socievolezza e di rapporti umani, da cui trarre un insegnamento o semplicemente una riflessione.
Convertitosi all'epicureismo, anch'egli alla ricerca di risposte sui grandi temi esistenziali, risposte che di fatto non troverà mai: il poeta sembra infatti non essere mai sfuggito all'angoscia della morte, percepita sempre come imminente. È interessante analizzare la visione che il poeta latino aveva dell'aldilà, in quanto è indubbiamente molto sincera: sebbene velata da una certa sicurezza, propria di quella "aurea mediocritas" di cui Orazio voleva essere esempio, in molteplici occasioni traspare una vena di malinconia, accompagnata da cupe note di lirismo e di elegia, che tradisce il suo reale stato interiore.
Orazio appare, a sprazzi, come quello che forse veramente era: un uomo che ha trovato nella vita il rifugio dalla morte, ma che in verità non è mai riuscito a curare del tutto la paura di essa, che preferisce fuggire piuttosto che combattere stoicamente. La sua personalità può quindi risultare, a una prima lettura, ambigua: tale ambiguità nasce dalla discordanza che talvolta si viene a creare tra l'immagine che Orazio voleva dare di sé, e la vera personalità del poeta che inevitabilmente trapela dalle righe: non a caso, come sostiene Ugo Enrico Paoli, "nulla [...] appare così difficile come penetrare nell'animo di Orazio". La rappresentazione dell'aldilà oraziano è comunque di forte stampo epicureo, e viene suggellata nel modo migliore nell'affermazione, non priva di una nota malinconica, espressa nell'Ode 7 del Libro IV (v. 16):
«Pulvis et umbra sumus»
ODE 7 libro IV
Si sono sciolte le nevi, ritornano ormai le erbe ai campi
e agli alberi le chiome;
la terra muta le sue forme e i fiumi che decrescono
scorrono lungo le rive.
Una Grazia con le ninfe e le sue due sorelle osa
guidare nuda le danze.
A non sperare cose immortali ammoniscono la stagione
e l’ora che trascina via il giorno datore di vita.
Il freddo si mitiga con gli Zefiri, la primavera
la calpesta l’estate, destinata a morire non appena
l’autunno ricco di frutti avrà riversato le sue messi, e subito
ritorna l’inverno che rende inerti.
I danni celesti, tuttavia, li riparano rapide le lune:
noi invece, una volta che siamo caduti
laddove [sono caduti] il padre Enea, il ricco Tullo e Anco,
siamo polvere e ombra.
Chi sa se gli dei del cielo aggiungono il domani alla somma
[dei giorni vissuti] finora?
Alle avide mani dell’erede sfuggiranno tutti i beni che
avrai concesso al tuo animo.
Non appena sarai tramontato e Minosse su di te
avrà pronunciato solenni giudizi,
o Torquato, non la tua nobile stirpe, non la facondia,
non il rispetto religioso ti restituiranno [alla vita].
Infatti né dalle tenebre degli Inferi Diana libera
il casto Ippolito
né Teseo è in grado di spezzare per il caro Piritoo
le catene infernali.

Quinto Orazio Flacco in un ritratto immaginario di Giacomo Di Chirico
In questa affermazione Orazio riesce a esprimere non solo il suo punto di vista sulla morte, ma anche l'angoscia che lo investe in vita, proprio in funzione del prossimo e certo annullamento dell'esperienza terrena. Dai versi di Orazio, quando il poeta parla della morte, risulta davvero difficile cogliere una nota di serenità, di gioia: il sentimento che invece predomina e che si identifica nella reazione psicologica del poeta di fronte alla morte, è una triste accettazione di un fatto naturale. In particolare questo sentimento viene espresso nell'Ode 14 del II libro, nella quale afferma (vv. 8 -12):
«...tristi
[...] unda, scilicet omnibus,
quicumquae terrae munere vescimur,
enaviganda, sive reges
sive inopes erimus coloni.»
ODE 14 Libro II
Ahimé fugaci, o Postumo, o Postumo,
scorrono gli anni, la pietà non porterà
impedimento alle rughe
e alla vecchiaia che incalza
e alla morte inesorabile
neppure se tu la placassi,
o amico,
con trecento tori;
tutti i giorni che passano,
l'illacrimato Plutone,
che il tre volte grande Gerione e Tizio
tiene chiusi con la sua triste onda,
che senza dubbio
dovrà essere oltrepassata da tutti noi,
quanti fruiamo dei doni della terra,
sia re sia umili coloni.
Inutilmente ci terremo lontani dal cruento Marte
e dai flutti infranti sul fragoroso Adriatico,
invano negli autunni temeremo
l'Austro dannoso ai corpi.
Dovremo vedere il nero Cocito
errante con lento corso
e la stirpe infame di Danao
e l'Eulide Sisifo,
condannato a eterna fatica.
Bisognerà lasciare
la terra e la casa e la sposa amata,
e di queste piante che coltivi
a parte gli odiosi cipressi,
nessuna ti seguirà padrone per breve tempo.
Un erede più degno assumerà Cècubo
conservato sotto cento chiavi
e bagnerà il pavimento
con il vino superbo
migliore di quello della cena dei pontefici.
Questi versi ci esprimono quanto Orazio percepisse la morte cupa e fonte di grande turbamento: viene qui rappresentata come una palude (unda, parola che già nel suono anticipa il concetto che sta per essere espresso, e rafforza il simbolismo di cui è oggetto: palude=morte), a cui accosta l'aggettivo "triste" (tristi), che reca con sé anche un profondo senso di inevitabilità. La palude a cui allude Orazio è lo Stige: in questo caso, il riferimento mitologico ha valore simbolico, ed è funzionale non solo a esprimere il concetto della morte, ma anche a rendere più vivida ed espressiva la poesia. Invece scilicet (come è naturale) afferma un dato di fatto: l'inevitabilità della morte, alla quale non vi è modo di sfuggire. Questo concetto in realtà viene qui ripetuto, ma era già stato espresso all'inizio dell'ode:
«...nec pietas moram
Rugis et instanti senectae
Adfert indomitaeque morti.»

Venosa, interno della casa di Orazio
Inutile e vana è la religione, incapace di porre un rimedio (moram) all'incalzante vecchiaia e alla morte: questo è il punto di vista del poeta riguardo alla religione, e traduce un sentimento diffuso ed esteso a tutta la romanità del secolo. La religione è ormai incapace di dare spiegazioni sufficienti riguardo alla vita dopo la morte, il fervore religioso (pietas) non potrà salvare l'uomo dalla sua naturale condizione di mortale.
È davvero grande la differenza che corre tra l'attacco e la critica che Lucrezio aveva fatto nei confronti della religio, accusata di offuscare la ragione e di far nascere inutili tribolazioni e angosce, e questa, che suona più come una triste constatazione dell'incapacità di essere rasserenati da una religione nella quale non si riesce più a credere. Centrale nei versi 8-12 è il gerundivo enaviganda, che esprime pienamente l'inevitabilità e la certezza della morte, non senza una nota di cupa e profonda malinconia, già anticipata da tristi unda. Risulta già chiara da questi pochi versi la percezione che Orazio aveva della morte, percezione che spiega e motiva la sua scelta di vita: una vita caratterizzata dal godere del presente e delle poche gioie che la vita ci offre (identificabili principalmente nell'amicizia, nel convivio, nella pace interiore) e che ci consentono di vivere con serenità e stabilità. Orazio appare a tratti molto pessimista: la morte è sempre in agguato e la vita potrebbe finire in ogni momento; è meglio, quindi, non riporre le proprie speranze nel domani. Questa idea di brevità della vita (che ritroviamo anche in Catullo: brevis lux) è un ulteriore invito a godersi la vita il più possibile, concetto che ritroviamo in numerosi versi, come nell'Ode 11 del libro I:
«...Dum loquimur fugerit invida
Aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.»
ODE 11 Libro I - Carpe diem
Tu non chiedere (è inutile saperlo) quale fine gli dei
Abbiano assegnato a me, quale a te, oh Leuconoe,
e non consultare la cabala babilonese.
Quanto meglio sarà sopportare qualsiasi cosa,
sia che Giove ci abbia assegnato molti inverni,
sia che che ci abbia assegnato l’ultimo,
che ora squassa il mar Tirreno sugli opposti scogli:
sii saggia, mesci il vino e recidi la lunga speranza poiché lo spazio è breve.
Mentre parliamo il tempo invidioso sarà già passato:
cogli l’attimo, fidandoti del futuro il meno possibile.
Orazio si rivolge a una ragazza ansiosa di conoscere il proprio futuro e le detta alcune semplici norme di una vita ideale di saggezza: bisogna accettare il proprio destino e godere il tempo presente vivendo ogni giorno come se fosse l’ultimo della nostra esistenza perché la vita è precari e fugace ed è praticamente impossibile sapere cosa ci riserverà il domani.Questo concetto deriva dalla filosofia epicurea.
Il tempo è in una fuga perpetua, che non lascia adito a speranze future: occorre sfruttare al massimo il tempo che ci è concesso, e considerare ogni momento che ci è dato come un dono, così come afferma nell'Ode 9, del libro I (vv.14-15: "...
Quem Fors dierum cumque dabit, lucro/Adpone..."); la sua concezione della fuga temporis sarà un perfetto modello per un grande poeta italiano come Francesco Petrarca, che, dopo aver letto classici come Orazio, Seneca e Agostino, lamenterà, nel
Canzoniere, la caducità del tempo e la sua essenza fuggitiva in liriche come
La vita fugge, et non s'arresta un'ora, molto vicina alla poetica oraziana. È chiaro dai suoi versi quanto la visione della morte condizioni in modo netto l'esperienza di vita del poeta, che ci viene vivacemente descritta dalla sua poesia: la morte non è, al contrario di quanto si crede, un evento che ci attende alla fine del nostro percorso vitale, ma è qualcosa che ci lasciamo dietro ogni giorno e dietro ogni momento, che estingue e brucia, attraverso il tempo, tutto ciò che è.

Le Odi di Orazio tradotte da Mario Rapisardi
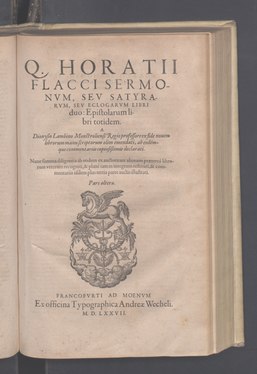
Horatii Flacci Sermonum, 1577
Opere
- Epodi (Epodon libri o Iambi, come li definisce l'autore), 17 componimenti, composti a partire dal 42 a.C. e pubblicati nel 30 a.C.
- Satire (Saturae o Sermones, come le definisce l'autore), in due libri che comprendono 18 satire, scritte tra il 41 e il 30 a.C.: il I libro (10 satire) fu dedicato a Mecenate e pubblicato tra il 35 e il 33 a.C., mentre il II libro (8 satire) fu pubblicato nel 30 a.C. insieme agli Epodi.
- Odi (Carmina, come li definisce l'autore), in tre libri con 88 componimenti, pubblicati nel 23 a.C. Un quarto libro con altri 15 componimenti venne pubblicato intorno al 13 a.C.
- Epistole, in due libri. Il I libro comprende 20 lettere composte a partire dal 23 e pubblicate nel 20 a.C., con dedica a Mecenate, mentre il II libro, con tre lettere, scritto tra il 19 e il 13 a.C., comprende l'epistola ai Pisoni, o Ars Poetica in 476 esametri, che fu presa a canone per la composizione poetica nelle epoche successive.
- Carme secolare (Carmen saeculare), del 17 a.C., scritto per incarico di Augusto e destinato alla cerimonia conclusiva dei ludi saeculares.
Eredità
Orazio è considerato dal classicismo uno dei più importanti poeti latini, citato ad esempio anche nell'Inferno di Dante nel Limbo, al verso 89 del canto IV.
Molte delle sue frasi sono diventate modi di dire ancora in uso: esempi sono carpe diem, nunc est bibendum e aurea mediocritas, oltre che Odi profanum vulgus, et arceo, e, recentemente, gli è stato intitolato anche un cratere sulla superficie di Mercurio.
SATIRE
I. 1 A Mecenate
Mecenate, onde vien, che nessun pago
Sia del mestier, ch’elezione o caso
Gli offerse, e lodi chi professa altr’arti?
O fortunati mercatanti, esclama
Carco d’età il soldato, a cui le membra
Fiaccò lunga fatica; e ’l mercatante,
Quando squassar dagli Austri sente il legno:
Migliore è la milizia. E chi n’ha dubbio?
Vassi al conflitto, e in un istante o pronta
Morte ti viene o lieta palma incontro.
Quando il giurista sul cantar del gallo
Picchiare ode i clienti alla sua porta,
Colma di lodi il campagnuol. Chi dati
Mallevadori è dalla villa a Roma
Citato a comparir, quelli soltanto
Che vivono in Città, felici appella,
Ma tanto innanzi va questa materia,
Che Fabio seccator ne avrìa soverchio.
Per non tenerti a bada ecco ove vanno
I miei detti a parar. Se un Dio dicesse:
I’ son qui pronto a far vostro desio:
Tu già soldato, in avvenir sarai
Mercante, e tu legal vivrai ne’ campi.
Su via cangiati impieghi ognun si parta.
Che state a far? Se così lor parlasse,
Nessuno il patto accetterebbe. Eppure
In vostra mano sta l’esser beati.
Forse che Giove non avria ragione
Di gonfiare adirato ambe le gote,
E dir che per lo innanzi esso non fia
Sì buon di dare agli uman voti orecchio?
Ma per non far come chi scherza e ride
Per baloccar la gente (eppur chi mai
Così blando maestro al fanciullino
Perchè impari abbiccì, dona le offelle)
Or dismesso il burlar battiam sul sodo.
Quei che il terren col duro vomer fende,
Il furbo oste, il soldato, il navigante
Che ardito solca il mar, vanno dicendo
Che volte son le lor fatiche e stenti
A procacciarsi il pan per la vecchiaja,
E assicurarsi un placid’ozio, come
La piccola formica, a noi di molta
Fatica esempio, quanto può col rostro
Dietro si tragge, e del futuro accorta
Via via l’abbica, ed il suo mucchio accresce.
Sì, ma costei, quando l’Aquario attrista
L’anno cadente, fuor non mette piede,
E l’ammassato gran si gode in pace.
Ma te non verno, o sollion, non fuoco
Nè mar nè ferro da lucrar distoglie,
Per non vedere alcun di te più ricco.
Che val sotterra por furtivamente
Con paurosa mano immenso pondo
D’argento e d’or? Perchè non si riduca,
S’io lo vada scemando, a un vil bajocco.
Ma se tu non lo spendi, e che ha di bello
La ragunata massa? or via poniamo,
Che tu nell’aja battut’abbia cento
Mila moggia di gran. Non la tua pancia
Per questo ne terrà più che la mia.
Qual se tra’ servi su le spalle un sacco
Di pan portassi, non ne avresti poi
Di chi scarco ne andò più largo pasto.
A chi sta di Natura entro a’ confini
Che mai vale arar cento o mille campi?
Bel gusto è provvedersi a una gran massa.
Purch’io dalla mia picciola altrettanto
Ne possa aver, qual di lodar motivo
Hai più delle mie corbe i tuoi granai?
Egli è come se un fiasco od una tazza
Bisognandoti d’acqua, i’ non vo’ torla,
Dicessi, a un fonticel, ma ad un gran fiume.
Quinci avviene a chi più del giusto agogna
Che insieme con la sponda il rovinoso
Offanto se l’assorba entro i suoi gorghi.
Ma chi ciò sol desia che a lui fa d’uopo
Nè a limacciosa pozza attigne l’acqua,
Nè a rischio d’affogar sua vita espone.
Ma da insana avarizia una gran parte
Degli uomini accecata ognor ripete:
Non evvi mai tanto che basti, ognuno
Tanto vale quant’ha. - Che vuoi tu farvi?
Lasciali star col lor malanno in pace.
Fuvvi in Atene un tal ricco spilorcio,
Che sprezzava i motteggi della gente
Fra se dicendo: Il popolo mi fischia,
Ma in casa io mi fo plauso allorch’i’prendo
A contemplare i miei danar nell’arca.
Tantalo sitibondo anela all’acqua,
Che gli fugge dal labbro... E che? tu ridi?
La favola è di te sotto altro nome.
Su que’ sacchi ammontati t’addormenti
A bocca aperta, nè tastargli ardisci
Qual se fossero sacri, e di lor godi
Non altramente che d’un pinto volto.
Tu no non sai qual giovamento ed uso
Abbia il danar. Si compri pane e vino,
Ortaggio, e quel di più che nostra frale
Natura sdegna che le sia negato.
Forse a te piace il vegghiar notte e giorno
Col batticuor, temendo ladri, incendj,
E schiavi che ti lascino in farsetto?
Io non curo tai ben punto ne poco.
Ma tu dirai: se le mie membra assale
Ria febbre, o s’altro mal m’inchioda in letto,
Ho chi m’assista, chi i fomenti appresti,
Che al medico ricorra, affinchè sano
E salvo mi ridoni alla mia gente.
Ah non la moglie e non il figlio brama
Che tu risani. A tutti in odio sei
Conoscenti e vicin, servi e fantesche.
Che maraviglia, se qualor posponi
Ogni cosa al danar, nessuno in petto
Nutre per te quel che non merti, amore?
Se i parenti che a te Natura diede,
Senz’opra alcuna vuoi serbarti amici,
Tu sciagurato il tempo getti invano
Qual chi insegnasse a un asinello in campo
Ir di galoppo, ed ubbidire al freno.
Se non altro abbia fin la tua ingordigia,
E quanto hai più, tanto minor paura
Ti faccia povertà; quando se’ giunto
A posseder quanto bramasti, allora
Almen ti metti in calma, e non far come
Un certo Uvidio (la novella è breve).
Ei ricco sì che misurar potea
Danari a staja, era sì sconcio e lordo,
Ch’iva peggio vestito d’uno schiavo,
Sempre temendo di morir di fame.
Una sua serva, nuova Clitennestra,
Con un’accetta lo segò per mezzo!
Ehi qual consiglio mi vuoi dar? Ch’io viva
Qual Nevio, o Nomentano? = E tu pur segui
Cose discordi ad accozzar tra loro.
Non io, qualor ti vieto essere avaro,
Vo’ che tu mi diventi un gocciolone
Ed uno sprecator. Qualche divario
Tra ’l suocer di Visello e Tanai passa.
Tutto ha le sue misure, oltra le quali
Nè di quà, nè di là risiede il retto.
Torniamo onde partimmo. E nessun dunque
Pago è di sè, come l’avaro, e quei
Che han preso altro cammin, colma di lodi?
E perchè la capretta del vicino
Più gonfio porta il sen, si va struggendo,
Nè alla turba maggior si paragona
De’ meno facoltosi, e questo e quello
Di trapassar s’affanna, ond’è che sempre
Altro più ricco fa al suo corso intoppo.
Quando son dalle mosse usciti i cocchi,
Di stare al pelo il carrettier si sforza
A’ corridor che vede innanzi a’ suoi,
E quei che addietro si lasciò non cura.
Quinci è che rado noi troviam chi dica
D’aver condotto i dì felici, e parta
Di qua contento, come chi si lieva
Da tavola satollo; e tanto basti.
Perchè non abbi a dir che di Crispino
Lippo involai gli scrigni, io qui m’arresto.
ODE, I,2
Mecena, o d’avi regj progenie,
Mio buon presidio, mio fregio amabile,
V’è chi sul plaustro la polve olimpica
Ama raccogliere: schivando il termine
Con ruote fervide, la palma merita
Ch’ai Numi innalzalo del mondo principi.
Gode un, se mobile turba quirinia
All’onor triplice lui cerca estollere;
Un, se nel proprio granajo accogliere
Può quanto trebbiasi nell’aje libiche.
Chi i campi patrj col sarchio fendere
Si piace, d’attali tesori smuovere
Così non lasciasi che in trave cipria
Seghi il mar mírtoo, nocchiero pavido.
S’africo infuria su’ flutti icarj,
Mercator trepido gli ozj e le patrie
Campagne lauda; ma pure, indocile
D’inopia, i logori legni ristaura.
V’è chi con pàtere di vecchio massico
L’ore indugevoli d’un poco abbrevia,
Or sotto un’arbore verde sdrajandosi,
Or presso al correre d’un sacro rivolo.
Non pochi i bellici campi ed il sonito
Di tube e litui e le pugne, orride
Alle madri, amano; caccia altri a rigido
Ciel, della tenera consorte immemore:
O i cani il daino fidi avvisarono,
O il cinghiai marsico le tese insidie
Ruppe. Me l’edere, di dotte premio
Fronti, ai celícoli mescon; me gelidi
Boschi e danze agili di ninfe e satiri
Scevran dal popolo, se mai la tibia
Non fia che neghimi Euterpe e degnisi
La cetra lesbia tender Polinnia.
Se tu fra’ lirici vati mi annoveri,
Toccherò l’ètera con arduo vertice.
IL CARME SECOLARE
Febo e Diana che su’ boschi avete possa,
Chiaro ornamento al ciel, sempre onorandi
Ed onorati, i preghi nostri udite
Nel tempo sacro,
In cui dal sibillin verso è prescritto,
Che agli Dei, cui son cari i sette colli,
Vergini elette e giovinetti casti
Dicano un canto.
Fecondo Sole, che su l’aureo cocchio
Apri e nascondi il giorno, e vario, uguale
Sorgi, deh, nulla mai veder tu possa
Maggior di Roma!
Benignamente, o Ilitía, dischiudi
Maturi i parti, e in guardia abbi le madri,
Sia che Lucina o Genital ti piaccia
Esser nomata.
Cresci le proli, o Dea, spira i decreti
Dei Padri intorno alle femminee nozze
Ed a la legge marital, di nova
Stirpe ferace:
Sì che dieci fíate in ciel rivolto
L’undecim’anno, adduca i canti e i giochi
Tre volte a chiaro giorno e tante a grata
Notte solenni.
E voi che vero ognor cantaste, o Parche,
Ciò che detto una volta un termin serba
Fisso alle cose, a’ già trascorsi unite
Fati benigni.
Di sementi e di pecore feconda
Serti di spiche a Cere offra Tellure;
Salutari acque e temperati cieli
Nutrano i parti.
Deposto il dardo, placido e clemente
Odi i preganti giovinetti, Apollo;
Le donzelle odi, regina bicorne
Degli astri, o Luna.
Se vostra opera è Roma, e il lido etrusco
Afferraron per voi le iliache squadre,
Che mutar lari e sede ebber comando
Con fausto corso,
E a cui di Troja in tra le fiamme illeso,
Superstite alla patria, il casto Enea
Libero aperse il varco, e dar maggiore
Regno doveva,
Donate, o Dei, probi costumi a’ pronti
Giovani, a’ vecchi placidi quiete,
Dovizia e prole alla romulea gente
E gloria intera.
Abbia da voi, cui bianchi tori immola
Di Venere e di Anchise il chiaro sangue,
Che altero in guerra col nemico e’ sia.
Mite col vinto.
Già l’armi nostre in terra e in mar possenti
E le bipenni albane il Medo teme;
Chiedon responsi già gli Sciti e gl’Indi
Or or superbi.
Già Fede, Pace, Onor, Pudore antico,
Virtù negletta attentansi al ritorno;
Già l’Abbondanza splendida col pieno
Corno si affaccia.
Oh, se alle rocche palatine amico
Febo augurante guardi, egli che, bello
Di fulgid’arco ed alle nove accetto
Camene, i corpi
Egri con salutare arte solleva;
Se d’Algido alle sedi e d’Aventino
Dei Quindici le preci oda Diana,
E con benigno
Orecchio accolga de’ fanciulli i voti,
Durerà Roma e il Lazio e d’uno ad altro
Lustro felice stenderà l’impero
Eternamente!
Che Giove ed ogni dio questo ne assenta,
Viva speranza e certa a casa io reco,
Io coro esperto ad esaltar nel canto
Febo e Diana.
ODE I,9 vv. 13-16
Quid sit futurum cras fuge quaerere et
quem Fors dierum cumque dabit lucro
appone, nec dulcis amores
sperne puer neque tu choreas,
Come andrà domani evita di chiedere,
ogni giorno in più che il cielo ci darà
consideralo un dono, e i dolci amori,
fanciullo, non sciupare, e neppure i balli,