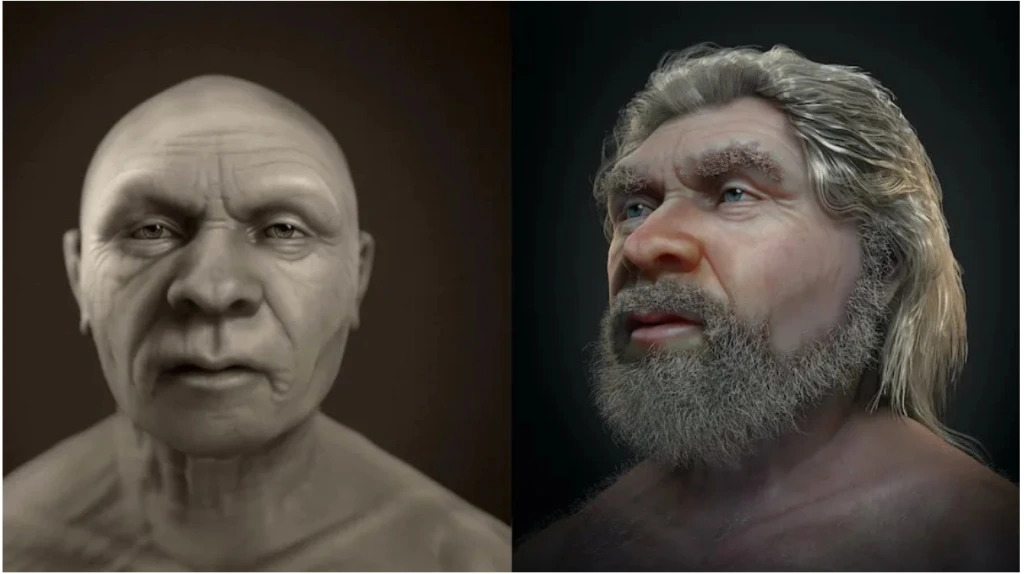La pistola fumante? È presto per dirlo, fu comunque un evento di grande significato evolutivo, che coincide con la data del bottleneck africano e che conferisce ulteriore importanza a questo passaggio, potendo segnalare l’origine evolutiva del LCA condiviso tra noi, i Neanderthal e i Denisova: alias Homo heidelbergensis.
L’umanità di mezzo
e la ricerca
dell’antenato.
Uno dei grandi enigmi dell’evoluzione umana
riguarda l’identità dell’ultimo antenato comune
tra noi e i Neanderthal. Prove di varia natura
puntano a Homo heidelbergensis

Riproduzione facciale forense di Homo heidelbergensis.
Solna (Stoccolma, Svezia), Karolinska Institut, 3
ottobre 2022. La professoressa Anna Wedell delinea
la figura del genetista e antropologo svedese
Svante Pääbo, partendo da queste parole:
«Who are we and where do we come from?» In effetti,
l’antichissima domanda «chi siamo e da dove
veniamo» è proprio quella che dà meglio il senso
della ricerca sulle origini e l’evoluzione dell’umanità, il campo di
studi per cui veniva in quel momento conferito il premio Nobel per
la fisiologia o la medicina.
Non era la prima volta che l’Accademia svedese premiava ricerche
non strettamente «mediche», basti pensare ai premi Nobel a James
Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins per la struttura del
DNA; a Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen e Karl von Frisch per il
comportamento animale; o a François Jacob, André Michel Lwoff
e Jacques Monod per la regolazione genica. Tuttavia era la prima
volta che il premio veniva assegnato nel campo della paleoantropologia
e anche la prima volta (quasi incredibile a dirsi) che nella
motivazione del premio veniva usata la parola «evoluzione».
Premio
più che meritato, d’altra parte: Svante Pääbo e il suo gruppo
di ricerca al Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie di
Lipsia, in Germania, sono stati i pionieri (nel 1997) e fra i principali
protagonisti di una nuova disciplina scientifica sviluppatasi come
un fiume in piena nel corso degli ultimi decenni: la paleogenomica.
Questo è un campo di studi che ha portato (fra gli altri risultati)
alla decifrazione del genoma dei Neanderthal, la specie umana
che conosciamo come ampiamente distribuita in Europa e Asia occidentale
fino a circa 40.000 anni fa. A partire dal 1997, affiancandosi ai dati paleoantropologici e archeologici, questi studi ci hanno
fornito una misura precisa dell’affinità fra i Neanderthal e noi,
anche in termini di avvenuti scambi genetici, per i quali individui
delle due specie si sono occasionalmente incrociati, lasciando ancora
oggi piccole quote del loro DNA nel genoma di tutti gli esseri
umani oggi viventi, con l’eccezione di popolazioni africane i cui
antenati non vennero mai in contatto con l’altra specie. Nondimeno,
diversi dati suggeriscono l’esistenza di barriere riproduttive,
seppur incomplete e asimmetriche, tra le due specie e, per quanto
esista un dibattito aperto tra studiosi di diversa formazione, rimane
il fatto che Homo sapiens e Homo neanderthalensis furono
effettivamente specie distinte, analogamente a lupi (Canis lupus)
e coyote (Canis latrans) che pure occasionalmente si incrociano
oggi in natura, producendo prole parzialmente fertile.
Allo stesso tempo, sono da considerare i dati della paleoantropologia
e le informazioni che essi ci forniscono a partire dalla
morfologia dei resti fossili. Da essi sappiamo che, nel corso del
tempo – nel Pleistocene Medio, per la precisione, compreso tra
780.000 e 125.000 anni fa circa – le linee evolutive delle due specie
avevano acquisito, rispettivamente a nord e a sud del Mediterraneo
e del Sahara, caratteristiche morfologiche tipiche e ben riconoscibili,
a seguito della separazione da un antenato comune,
avvenuta ben prima che le due specie prendessero una loro precisa
identità e venissero a incontrarsi, e a incrociarsi, così come avvenne
nel momento in cui una delle due (Homo sapiens) iniziò a
diffondersi dall’Africa verso l’Eurasia.
Chi era questo ultimo antenato comune (o Last Common Ancestor,
in seguito LCA)? Quali caratteristiche aveva? Quanto tempo
fa è vissuto? Come viveva? Proveremo a rispondere a queste
domande nelle pagine che seguono. Un po’ come in un’indagine
«poliziesca», andremo alla ricerca e all’identificazione di un LCA
che rimane (almeno in parte) misterioso, sfuggente e controverso.
Confrontando il genoma dei Neanderthal con quello degli esseri
umani moderni e applicando le tecniche del cosiddetto orologio
molecolare, è possibile risalire all’orizzonte temporale in cui le rispettive
linee evolutive hanno iniziato a divergere, un evento noto
come «punto di coalescenza». Questo momento si colloca interamente
nel Pleistocene, precisamente nel Pleistocene Medio, ricadendo
in un intervallo cronologico stimato – in base ai diversi marcatori
genetici usati, nucleari e mitocondriali – tra circa 450.000 e
750.000 anni fa, con una media attorno a 600.000.
Si tratta di un indizio importante. Ci suggerisce infatti che,
prima e durante questo periodo, sia esistita una specie ancestrale
non ancora chiaramente definita in senso né moderno né
Neanderthal, ma con tratti che potrebbero essere stati ereditati
da entrambe le specie. Indica anche che dovremmo trovare nel
record fossile successivo tracce di popolazioni che, a seguito di
eventi di dispersione, si separarono in differenti aree geografiche
pur rimanendo ancora riferibili tassonomicamente alla specie ancestrale.
Da tenere a mente che queste popolazioni semi-isolate
(anche dette «paleodemi») hanno continuato nel tempo a sviluppare
caratteristiche che progressivamente le avvicinavano all’umanità
moderna da un lato e ai Neanderthal dall’altro, lungo le rispettive
linee di evoluzione geografica e filogenetica.
Dobbiamo precisare che il punto di coalescenza delle linee filetiche non rappresenta né l’uno né l’altro evento di origine delle
nuove specie. In linea teorica, esso si riferisce al momento in
cui alcune popolazioni, probabilmente a seguito di separazione
geografica e conseguente ridotto flusso genico, iniziano ad accumulare
differenze che solo successivamente portano all’origine
di nuove specie, con l’insorgere di barriere riproduttive più o
meno complete. Lo studio dei fossili e del DNA antico può aiutare
a determinare quanto tempo dopo la separazione delle rispettive
linee evolutive Neanderthal e uomini moderni si siano effettivamente
differenziati in due specie distinte. Questo ci permette
di stabilire il limite temporale entro il quale cercare LCA, perché
questo antenato deve necessariamente essere vissuto prima della
loro caratterizzazione genetica e morfologica.
I fossili riferibili a Neanderthal o a Homo sapiens (anche quelli
più antichi) si riconoscono per una serie di caratteristiche uniche
e costanti che li differenziano tra loro e dalle forme umane
precedenti. Per esempio, i Neanderthal hanno una scatola cranica
voluminosa e molto allungata in senso antero-posteriore con alcuni
rilievi ossei tipici, che sono visibili nella parte posteriore (occipitale)
e anteriore (frontale). Soprattutto, con un profilo che può
essere inscritto quasi perfettamente all’interno di un’ellisse se il
cranio viene osservato da dietro.
Il profilo ricurvo dei parietali, che viene definito en bombe, è il
risultato della riorganizzazione e dell’espansione laterale di alcune
aree cerebrali che secondo l’interpretazione del paleoneurologo
Emiliano Bruner, italiano ma già da anni in Spagna e ora in
forza al Museo di storia naturale di Madrid, si collegano a un’accresciuta
coordinazione psico-motoria. Si tratta quindi di un cambiamento
evolutivo importante, che segna anche un certo grado
di discontinuità.
È un buon indizio di una avvenuta speciazione, insomma. Fossili
con questa caratteristica sono quindi identificabili come i primi
Neanderthal e compaiono nel record fossile circa 250.000 anni
fa, inizialmente in Europa e successivamente anche nel Vicino
Oriente. Tuttavia, negli stessi territori europei, ma con cronologie
più antiche (tra 250.000 e 500.000 anni fa circa), troviamo
fossili che possiamo definire ante-Neanderthal, poiché condividono
(in vario grado) con i successivi Neanderthal alcune morfologie,
come il prognatismo medio-facciale e altri tratti morfologici
della regione occipitale del cranio. Anche l’orizzonte culturale
cambia contestualmente: dopo il MIS 8 (stadio isotopico marino,
MIS appunto, che indica una fase fredda all’incirca corrispondente
all’intervallo 250.000-300.000 anni fa) compare in Europa il
Paleolitico Medio, avanzato rispetto al precedente Paleolitico Inferiore
di Modo 2 o Acheuleano, caratterizzato quest’ultimo dalla
presenza di strumenti a scheggiatura bifacciale e a forma di mandorla
– i cosiddetti «bifacciali» acheuleani, o «amigdale» o «asce a
mano» – e tipicamente associato in Europa alle popolazioni che
precedono i Neanderthal.
La paleogenomica ci dice che tutta la variabilità genetica osservata
nei Neanderthal ha un punto di coalescenza tra 316.000
e 219.000 anni fa (con una media di circa 270.000), per quanto riguarda
il DNA di origine mitocondriale, mentre la variabilità del
DNA nucleare ha un’origine che è stimata attorno a 150.000 anni
fa (tra 199.000 e 125.000). Va ricordato che il DNA mitocondriale,
esterno al nucleo delle cellule, è trasmesso esclusivamente per
via materna e offre una prospettiva lineare alla ricostruzione delle
genealogie – non subendo ricombinazione, come peraltro accade
anche per il DNA del cromosoma Y (che si trasmette invece per
via paterna) – rispetto a quelle derivate dal DNA nucleare (cromosoma
Y a parte) che è soggetto a ricombinazione. I genetisti, comunque,
non sono molto contenti di questa discrepanza di date,
tanto da ipotizzare che tra 250.000 e 300.000 anni fa possa essere
avvenuta una sostituzione completa del genoma mitocondriale
e del cromosoma Y dei Neanderthal da parte di misteriose popolazioni
provenienti dall’Africa. Se però teniamo conto dell’errore
statistico – diciamo noi, facendo un’ipotesi meno rocambolesca
– le date della paleogenomica sono in accordo con quanto ci raccontano
i fossili e soprattutto, insieme a questi, ci dicono che l’origine
evolutiva di Homo neanderthalensis come specie si colloca
non molto oltre 250.000 anni fa circa.
Similmente ai Neanderthal, gli studi sull’origine della variabilità
genetica moderna indicano un punto di coalescenza per il
DNA nucleare risalente a oltre 140.000 anni fa, con un’origine interamente
africana per quello che Aaron P. Ragsdale e collaboratori
hanno chiamato il ramo principale (stem 1) della nostra specie
– in un articolo su «Nature» del 2023 – e che include gli antenati
di tutte le popolazioni attuali, sia africane che non africane. D’altra
parte, la variabilità associata al DNA mitocondriale, nell’ipotesi
della cosiddetta «Eva mitocondriale» formulata già nel 1987,
suggerisce un’origine africana attorno a 200.000 anni fa. A questo
orizzonte cronologico fanno riferimento fossili rinvenuti in
Etiopia: a Omo-Kibish, a sud, e nella media valle del fiume Awash,
più a nord. Sono questi, non altri – come, per esempio, i fossili
di Jebel Irhoud, in Marocco, considerati da alcuni autori (impropriamente
a nostro avviso) come forme arcaiche della nostra specie
– i più antichi reperti paleoantropologici con caratteristiche
morfologiche distintive di Homo sapiens. Che sono: un cranio voluminoso
e globulare, accompagnato da un mento sporgente, oltre
ad altri aspetti del cranio e della faccia maggiormente condivisi
fra i diversi fossili africani dello stesso periodo.
In parallelo, ma in modo divergente dalla forma allungata e
bassa del cranio dei Neanderthal, la forma globulare del cranio
rappresenta una discontinuità evolutiva molto significativa. Si
ritiene – sempre in accordo con l’interpretazione data originariamente
da Bruner nel 2003 – che sia in rapporto a potenzialità
cognitive sofisticate, in virtù di una completa riorganizzazione
cerebrale, con un’espansione come a ventaglio e verso l’alto
dei lobi parietali dell’encefalo. Tutto questo nel contesto, condiviso
con altre popolazioni africane dell’epoca, di un cambio di orizzonte
culturale che vede il passaggio da culture litiche del Paleolitico
Inferiore (o Early Stone Age) a a quelle del Paleolitico Medio
(Middle Stone Age).
Dunque, l’intervallo cronologico tra 250.000 e 200.000 anni
fa – in Europa e in Africa, rispettivamente – segna il limite più recente
per l’individuazione del nostro ultimo antenato comune, oltre
che l’origine evolutiva (speciazione) di Homo neanderthalensis
e di Homo sapiens.
Circa l’origine di LCA bisogna ricorrere ancora una volta a stime
di coalescenza, ma andando a ritroso. Abbiamo detto che
quella tra le rispettive linee evolutive nostra e dei Neanderthal
punta a un intervallo compreso tra 600.000 e 750.000 anni fa,
ma quanto indietro dobbiamo spingerci? Qui entra in gioco un
colpo di scena degno di un thriller di Ken Follett. Dalle nebbie di
una storia che ha del magico, emerge una sorta di «terzo gemello
»: un’altra specie umana estinta, sconosciuta alla scienza fino
a solo 15 anni fa. Si ritiene che questa specie (o varietà, visto
che non ha ancora un nome in latino)
sia strettamente imparentata con
Neanderthal e uomini moderni, e
anch’essa discenda dello stesso LCA
che stiamo cercando.
La conosciamo dal 2010, quando –
analizzando un piccolo frammento osseo,
la falange di un dito mignolo, quasi
un nonnulla dal punto di vista anatomico,
di un individuo giovane proveniente dalla grotta di Denisova,
nei monti Altai, in Siberia, quasi al confine con la Mongolia
– proprio il gruppo di Pääbo ha scoperto che il DNA mitocondriale
estratto era differente sia da quello dei Neanderthal sia dal nostro.
Questo dato suggeriva che, nonostante il reperto avesse circa
50.000 anni, la sua origine evolutiva risalisse a circa un milione
di anni fa. Da allora, l’umanità del tardo Pleistocene che quel frammento
d’osso rappresenta con tanta dovizia di informazioni genetiche
prende il nome dalla grotta in Siberia dove è stato trovato:
sono «i Denisova». Le successive analisi ricavate dal DNA (nucleare,
questa volta) hanno mostrato una considerevole affinità con
i Neanderthal e una separazione dalla linea evolutiva dei moderni
tra 600.000 e 700.000 anni fa circa.
I Denisova ci forniscono, con le loro caratteristiche genetiche,
un elemento in più per circoscrivere la ricerca del nostro LCA. Il
limite inferiore della sua origine evolutiva, posto attorno a un milione
di anni fa o non molto dopo, sembra più che plausibile per
indicare l’epoca di origine di LCA. Le analisi genetiche sui reperti
della grotta di Denisova – tutti frammenti ossei e denti isolati dalla
morfologia piuttosto arcaica, compatibile con un’origine antica
– e quelle comparative ci dicono anche molto altro. Per esempio ci
dicono che i Denisova, come i Neanderthal, si sono incrociati con
le bande di cacciatori-raccoglitori della nostra specie in espansione
fuori dall’Africa. Non tutte le popolazioni extra-africane attuali
ne recano le tracce, per lo meno non nella stessa misura, e l’introgressione
(cioè l’acquisizione nel nostro genoma) di geni di provenienza
denisoviana riguarda perlopiù popolazioni di origine asiatica,
con percentuali che arrivano quasi al 6 per cento in alcune
popolazioni delle Filippine e della Melanesia. Sappiamo inoltre
che vi furono incroci anche tra Denisova e Neanderthal, ed è stato
addirittura rinvenuto un resto osseo che si è rilevato appartenente
a un ibrido di prima generazione: era di sesso femminile ed
era la figlia di una madre Neanderthal e di un padre Denisova, che
a sua volta mostrava tracce di precedenti ibridazioni che potremmo
definire «transiberiane». Formidabile!
Resti fossili riconosciuti su base genetica come Denisova sono
a oggi estremamente scarsi e riguardano, oltre ai frammenti ossei
e ai denti della grotta omonima, anche una mandibola scoperta a
Xiahe, sull’altopiano del Tibet, e alcuni denti isolati in Laos. In base
a queste evidenze fossili – ma anche i dati genetici dicono molto
al riguardo – possiamo supporre che il territorio occupato un
tempo dai Denisova fosse estremamente vasto, andando a occupare
buona parte dell’Asia continentale. Non abbiamo però reperti
fossili che possano chiarire la morfologia dei Denisova. Ci sono
alcune ipotesi plausibili, tra le quali spicca un cranio eccezionalmente
ben conservato e scoperto a Harbin, nel nord-est della
Cina, datato a oltre 150.000 anni fa, che presenta una morfologia
dentale arcaica, compatibile con quella dei denti della grotta di
Denisova e della mandibola di Xiahe.
Questo e altri fossili con caratteristiche
simili (fra cui i crani di Dali e di Jinniushan, sempre
in Cina) mostrano un mosaico di caratteristiche tali da suggerire
un’evoluzione nel continente asiatico che ha portato all’emergere
dei Denisova da popolazioni più arcaiche, in modo simile a quanto
avvenuto in Europa per i Neanderthal e per noi in Africa.
Va detto, come tra parentesi, che questi fossili sono contemporanei
alla fase terminale di esistenza di un’altra specie
umana, ampiamente diffusa in Asia continentale e peninsulare,
cioè in Indonesia, dove sappiamo essere sopravvissuta fino a
quasi 100.000 anni fa e che conosciamo bene come Homo erectus.
Non potrebbe essere proprio questo il LCA che stiamo cercando?
Diciamo subito che la risposta è negativa. L’origine evolutiva di
questa specie è estremamente antica, arrivando a circa 1,8 milioni
di anni fa, il doppio di quanto suggerito dai dati della paleogenomica,
e le sue caratteristiche mal si armonizzano con quelle del
possibile LCA.
Proviamo a riassumere i dati che abbiamo finora raccolto per
circoscrivere, intanto nel tempo e nello spazio, l’identità del nostro
LCA: un’origine evolutiva che si colloca al passaggio tra il Pleistocene
Inferiore e Medio, cioè successivamente a un milione di anni
fa, e che ha lasciato rappresentanti fossili fino a circa 250.000-
200.000 anni fa, quando compaiono tre distinte specie (se
anche i Denisova lo sono); una diffusione in un vasto areale geografico
comprendente Africa ed Eurasia al cui interno si riconoscono
popolazioni semi-isolate in via differenziamento (paleodepromi),
dalle cui dinamiche evolutive ed ecologiche emergono infine
le suddette tre specie, rispettivamente in Asia, Europa e Africa:
Denisova, Neanderthal e uomini moderni.
Se le cose stanno così, già prima di 600.000 anni fa ci aspettiamo
di trovare morfologie ancora arcaiche, ma in una certa misura
caratterizzate verso i paleodemi successivi, distinguibili comunque
da forme umane a loro contemporanee (come Homo erectus)
e con volumi cerebrali importanti (a partire da 1200 cm3). D’altra
parte, i dati archeologici a disposizione indicano che qualcosa
cambia in Eurasia a partire da circa 700.000 anni fa, quando si
osserva una marcata diffusione di industrie dell’Acheuleano (evidenze
più antiche restano controverse), con gli iconici strumenti
bifacciali, la cui tempistica di diffusione si accorda bene con l’arrivo
di nuove popolazioni.
Com’erano dunque fatti e chi erano (in termini tassonomici)
gli esseri umani di queste nuove popolazioni? Esiste nel record
fossile del Pleistocene Medio qualcosa che corrisponda a un
possibile identikit? A nostro avviso sì, ma è proprio qui che il dibattito
tra gli specialisti si fa intenso, rendendo il caso-studio particolarmente
controverso. Infatti la natura «a mosaico» e la grande
eterogeneità di morfologie dei reperti africani ed eurasiatici
concorre a confondere l’interpretazione tassonomica. Alcuni paleoantropologi
esprimono questa frustrazione con l’espressione
muddle in the middle, letteralmente la «confusione nel mezzo»: riferendosi
sia al Pleistocene Medio sia a questa umanità «di mezzo
» che evolutivamente si interpone tra le forme più arcaiche del
genere Homo (come Homo erectus) e quelle derivate, come noi, i
Neanderthal e i Denisova.
Nel contesto di questa controversia, alcuni studiosi hanno
puntato la loro attenzione su una specie denominata Homo antecessor,
i cui resti, di poco oltre 780.000 anni fa, sono stati rinvenuti
unicamente nel sito della Gran Dolina nella Sierra di Atapuerca,
in Spagna. Alcuni frammenti scheletrici (una porzione di mandibola
e parte di una faccia) provenienti da un altro sito di Atapuerca,
la Sima del Elefante, hanno restituito un’età di oltre 1,2 milioni
di anni fa: sono quindi i più antichi mai trovati in Europa occidentale,
ma al momento non è affatto detto che possano riferirsi alla
stessa specie.
Rappresentativo di Homo antecessor è il cranio parziale di un
giovane rinvenuto nello strato TD6 della Dolina, che presenta
una morfologia facciale gracile e scavata, con un’ampia fossa
sul mascellare, di aspetto «moderno» e differente dalla morfologia
dei Neanderthal. Tuttavia, questa somiglianza potrebbe essere
superficiale, condivisa con altre forme umane arcaiche, o
influenzata dalla giovane età dell’individuo. Un tentativo di caratterizzare
i reperti della Gran Dolina tramite l’analisi delle proteine
– un approccio innovativo noto come paleoproteomica – ha prodotto
risultati contrastanti. I resti della Gran Dolina sono inoltre
associati a industrie su ciottolo del Paleolitico Inferiore di Modo
1 (il cosiddetto Olduvaiano), cioè prive di bifacciali, e anche questo
gioca contro l’idea che Homo antecessor possa essere l’atteso
LCA, oltre al fatto che la sua distribuzione geografica confinata in
un unico sito spagnolo rende difficile considerarlo come l’unico
rappresentante di un progenitore comune che doveva essere ampiamente
distribuito. È possibile, invece, che Homo antecessor sia
una sorta di «ramo morto dell’evoluzione umana in Europa, poiché
non sarebbe sopravvissuto a una rigida fase glaciale in corrispondenza
del MIS 16 (circa 680.000 anni fa), senza avere relazioni
dirette con l’umanità successiva.
È proprio dopo il MIS 16 che compaiono in Europa i più antichi
strumenti litici sicuramente attribuibili all’Acheuleano, tra
cui i bifacciali, insieme a resti umani
con caratteristiche diverse da quelle
di Homo antecessor, come nel sito
di Venosa-Notarchirico, in Basilicata,
risalente a circa 650.000 anni fa, il
più antico nel continente dove si rinviene
questa associazione. Proprio
questi uomini, in base all’identikit
che abbiamo tracciato, sono i primi
rappresentanti, sul versante europeo,
del tanto ricercato LCA.
Tra i resti fossili distribuiti in Europa
dopo il MIS 16 troviamo una
mandibola rinvenuta nel 1907 in depositi
sabbiosi a Mauer, in Germania,
vicino a Heidelberg, da cui lo
sfuggente LCA che cerchiamo prende
il suo appellativo scientifico: Homo
heidelbergensis. Il nome fu coniato
già nel 1908, ma solo verso la fine
del XX secolo è stato rivalutato come
possibile buona specie del Pleistocene Medio, a sua volta candidata
al ruolo di LCA. Il fatto che il rappresentante di questa specie –
il primo storicamente noto alla scienza, tanto da fornire il nome
tassonomicamente valido Homo heidelbergensis – sia una mandibola
isolata, non ha reso e tuttora non rende facile il confronto
con altri reperti.
Tuttavia, questo fossile mostra una morfologia generalizzata
e arcaica, ma già simile per alcuni tratti importanti a quella dei
Neanderthal in accordo con il cosiddetto accretion model. Secondo
l’ipotesi oggi più accreditata, l’evoluzione dei Neanderthal sarebbe
avvenuta mediante un processo di graduale accumulazione
di tratti distintivi in condizioni di parziale isolamento genetico.
Questo modello interpretativo prevede diverse fasi in successione
cronologica nel corso delle quali i reperti di Homo heidelbergensis
in Europa hanno sviluppato caratteristiche cranio-facciali
sempre più derivate, oltre a corporature adatte ai climi freddi,
fino ai Neanderthal tipici e cosiddetti «classici» del Pleistocene
superiore (a partire da circa 125.000 anni fa). Ci sono tuttavia reperti
europei della stessa età cronologica che non rientrano nello
schema dell’accretion model, poiché sono caratterizzati da morfologie
arcaiche e vicine ai reperti coevi africani e asiatici. Fra essi
c’è da ricordare il cranio purtroppo frammentario rinvenuto esattamente
trent’anni fa (nel 1994) vicino Ceprano, nel Lazio meridionale,
mentre tipicamente ante-Neanderthal sono i fossili dello
straordinario campione rinvenuto in un altro sito della Sierra de
Atapuerca, vicino Burgos, in Spagna: la Sima de los Huesos.
Il modello che comunque ne emerge (l’accretion model, appunto)
suggerisce che i cambiamenti evolutivi siano stati influenzati
dai cicli di espansione e ritiro dei ghiacciai durante la seconda
metà del Pleistocene Medio. Durante le glaciazioni, le popolazioni
di Homo heidelbergensis trovavano condizioni favorevoli nelle regioni
meridionali dell’Europa, che servivano da rifugio (la penisola
italiana, per esempio, bordata dalla possente barriera geografica
delle Alpi) e/o da fonte di innovazioni evolutive (la penisola iberica,
verosimilmente). Queste novità – che sono poi le caratteristiche
tipiche dei Naenderthal – potevano diffondersi successivamente,
nelle fasi temperate, in tutto il continente e sembrano averlo fatto
lungo un gradiente latitudinale di
diffusione da ovest verso sud-est.
Diversi autori però hanno contestato
il fatto che Homo heidelbergensis
possa essere davvero LCA,
perché i fossili generalmente riferiti
a questa specie sono successivi a
600.000 anni e nei diversi continenti
di Europa, Africa e Asia mostrano
già (anche se non sempre) morfologie
derivate, come abbiamo ora visto
nel caso particolare dell’Europa.
Ciò
è vero se non si tiene conto dell’origine
evolutiva antica di questa specie,
precedente alla separazione delle
linee filetiche evidenziata dai dati
genetici. Una recente scoperta – che
ci porta alla conclusione della nostra
indagine – permette di fare luce anche
su questo aspetto decisivo.
Uno studio condotto per alcuni
anni – pubblicato da «Science» nel settembre del 2023 e al quale
noi stessi abbiamo partecipato, insieme a una squadra di genetisti
e bioinformatici cinesi, guidati dal Haipeng Li, dell’Accademia
cinese delle scienze – ha portato a ricucire sempre più indietro
nel tempo, in base al principio di coalescenza, le relazioni genealogiche
insite nel genotipo di migliaia di individui appartenenti
a 50 popolazioni attuali, arrivando a tempi che precedono la
comparsa della nostra specie. Si è così scoperto che tra 800.000 e
900.000 anni fa circa i nostri antenati cacciatori-raccoglitori che
vivevano in Africa sperimentarono un drastico calo demografico
– quello che viene definito un bottleneck (o collo di bottiglia,
un particolare tipo di deriva genetica) – che li condusse sull’orlo
dell’estinzione. Avvenne esattamente in corrispondenza con il
picco, posto a circa 900.000 anni fa, di quella che i paleoecologi
chiamano «transizione medio-pleistocenica», che causò l’estinzione
e il rinnovamento di intere comunità faunistiche in Africa e
in Eurasia a seguito dell’ampliarsi degli effetti dei cicli glaciali fino
a quel momento molto meno intensi e ancora prima del tutto
assenti.
A risentire fortemente di quel collasso ecologico furono anche
le popolazioni di uomini arcaici della variante africana di Homo
erectus (detta anche Homo ergaster), le cui testimonianze fossili
non si rinvengono più proprio a partire da quella data, mentre sono
ben evidenti fino a circa 900.000 anni fa. A seguire, non si rinvengono praticamente più resti fossili umani in Africa, ma questi
tornano a essere relativamente abbondanti solo dopo 650.000
anni fa, con reperti dai volumi cerebrali maggiori, sopra i 1200
cm3 in media, e una morfologia che può essere attribuita proprio
a Homo heidelbergensis.
Riteniamo dunque che il bottleneck successivo a 900.000 anni
fa sia stato un evento tanto catastrofico quanto generativo,
nel quale alcune popolazioni umane (in certi momenti poco
più di 1000 individui fertili) riuscirono a sopravvivere in qualche
area rifugio, come per esempio potrebbe essere stato, in quel lungo
periodo di estrema aridità climatica, l’altopiano etiope. Ce lo
suggerisce il fatto che gli unici resti umani che ricadono nel gap
che si riscontra nel record fossile africano sono frammenti cranici
di circa 850.000 anni fa – rinvenuti su quell’altopiano, nel sito
di Gombore, e da noi presi in esame qualche anno fa – che mostrano
una morfologia intermedia tra gli umani più arcaici (Homo
ergaster/erectus) e i successivi Homo heidelbergensis. C’è da sottolineare
che in questi contesti di forte rarefazione demografica
e di isolamento geografico – in base a un modello evoluzionistico
identificato negli anni settanta da Stephen Jay Gould e Niles
Eldredge, noto come «equilibri intermittenti» – è probabile che
possano avvenire fenomeni di speciazione, dal momento che i
normali equilibri ecologici e genetici vengono sconvolti e un ruolo importante è svolto dalle pressioni selettive, combinate sia con
l’isolamento della popolazione sia con l’endogamia al suo interno.
Così, in conclusione, potrebbe essere comparso sulla scena
l’ultimo antenato comune che abbiamo cercato di identificare in
questa indagine «poliziesca»: Homo heidelbergensis. Il possibile,
anzi probabile, evento di speciazione, inoltre, sembra aver coinciso
(sorprendentemente) con un cambiamento genetico significativo
sul quale ci si era a lungo interrogati. Ci riferiamo alla riduzione
del numero di cromosomi – dai 48, che è proprio delle grandi
scimmie antropomorfe: scimpanzé, gorilla e orangutan, ai 46 di
Homo sapiens – dovuta alla fusione di due cromosomi ancestrali
in uno solo (il nostro cromosoma 2). Questa drammatica mutazione
cromosomica con il conseguente cambiamento macroevolutivo
– che in passato si sarebbe potuto pensare avesse determinato
fenomeni cruciali della nostra evoluzione, come l’origine dei primi
ominidi bipedi, intorno a 6 milioni di anni fa, o la comparsa del
genere Homo, circa 2,5 milioni di anni fa – sembra invece essere
avvenuta (secondo analisi di coalescenza di uno studio pubblicato
nel 2022) proprio intorno a 900.000 anni dal presente.
La pistola fumante? È presto per dirlo, fu comunque un evento
di grande significato evolutivo, che coincide con la data del bottleneck
africano e che conferisce ulteriore importanza a questo passaggio,
potendo segnalare l’origine evolutiva del LCA condiviso
tra noi, i Neanderthal e i Denisova: alias Homo heidelbergensis.
di Fabio Di Vincenzo e Giorgio Manzi
Il fenomeno detto collo di bottiglia identifica un particolare tipo di deriva genetica. Si verifica quando il numero di individui facenti parte di una popolazione viene ridotto drasticamente da forze atipiche nella selezione naturale (caccia, persecuzioni) o ne viene isolata definitivamente una parte (spostamenti migratori anomali, barriere geografiche).
Se solo una parte esigua della popolazione generale sopravvive, o comunque sopravvive isolata dal resto della popolazione generale, tali sopravviventi possono, per il passaggio attraverso un "collo di bottiglia" metaforico, recare solo il proprio corredo genetico, che non risulta quindi significativo di tutta la popolazione generale della propria specie di origine.
La conseguente riduzione della variabilità genetica può giungere alla criticità e tendere a eliminare del tutto alcuni alleli, ma anche a far sì che altri vengano rappresentati in eccesso nel pool genico. Come esempio si può studiare il restringimento della popolazione maschile discesa dall'Aplogruppo I (Y-DNA)
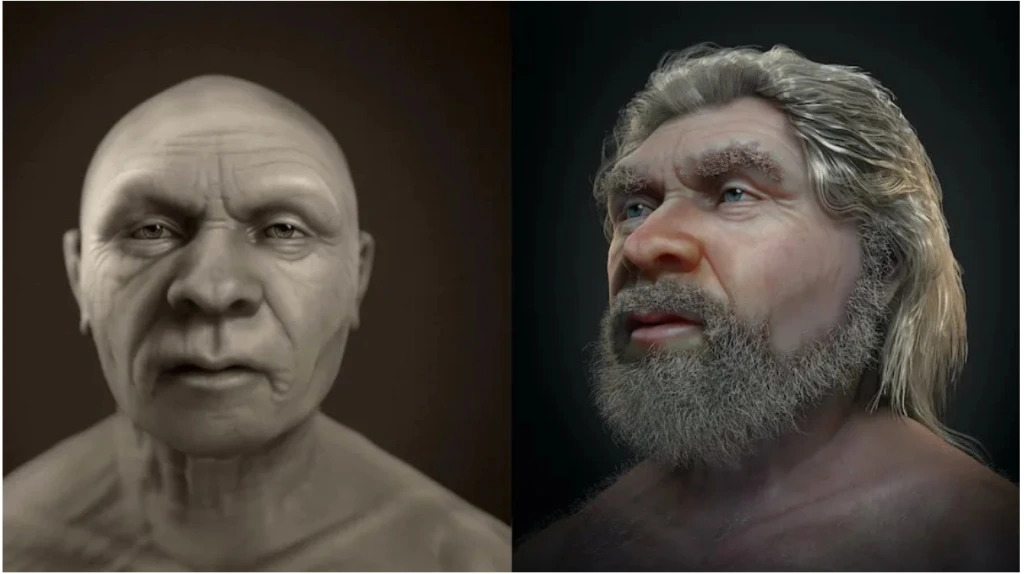
Ricostruzione facciale dell’uomo di Neanderthal ritrovato a La Chapelle aux Saints
I Neanderthal sono tra noi. Meglio, dentro di noi: con varianti di geni che hanno a che fare con alcune caratteristiche di capelli, unghie e pelle, e che potrebbero averci avvantaggiato in un ambiente freddo. Ma anche con varianti correlate al diabete di tipo 2, alla malattia di Crohn, alla cirrosi biliare, al lupus. Sarebbe questa l'eredità dei Neanderthal che noi sapiens ci portiamo dietro da almeno 40 mila anni. Non tutti allo stesso modo, ma chi più e chi meno: tra i più ci sono le popolazioni europee e dell'Asia dell'Est; tra i “meno” quelle africane, i cui antenati non hanno avuto occasione di entrare in contatto con gli antichi cugini (che vivevano, per l'appunto, in Europa e in Asia). Si stima che, in media, tra l'1 e il 3% del genoma di ogni essere umano moderno arrivi dai Neanderthal, ma si parla di un 20%, forse di un 30%, se invece si considera complessivamente tutto il materiale genetico che potrebbero averci tramandato.
I Neanderthal vivevano in Europa e Asia , i Sapiens in Africa. Qunado iniziò la grande migrazione dei Sapiens verso Nord, i Neanderthal iniziarono a scomparire, forse sopraffatti dal gene dell'aggressività dei Sapiens.
IL GENE DELL'AGGRESSIVITA' NELL'HOMO SAPIENS
L’aggressività può avere radici genetiche. È quanto suggerisce uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences che ha analizzato i meccanismi neurali del comportamento violento legato alla presenza di particolare gene: MAO-A. Una versione di questo tratto di Dna, contenente le istruzioni per un enzima che regola messaggeri chimici dell’umore (tra cui la serotonina) sembra infatti indebolire i circuiti neurali del cervello, e predisporre ad azioni impulsive. Secondo i ricercatori del National Institute of Mental Health degli Nih statunitensi che hanno realizzato la ricerca, la variante genetica, presente sul cromosoma X, ha effetti più di frequente sugli uomini, rispetto alle donne. Infatti, i maschi hanno un solo cromosoma sessuale X, contro le due copie delle femmine, che hanno quindi una probabilità più alta di essere in possesso della variante più “pacifica” del gene. Attraverso la risonanza magnetica cerebrale i ricercatori hanno scoperto che gli uomini sono più colpiti da immagini aggressive, che stimolano l’amigdala, una piccola struttura neurale che presiede alle emozioni, e possono innescare comportamenti violenti. Allo stesso modo è stata riscontrata una minore attività nelle zone che regolano le sensazioni di timore e paura, come la corteccia orbito-frontale. Il campione maschile dello studio, inoltre, aveva un’attivazione più debole della zona del cervello che inibisce gli impulsi violenti.
Eugenio Caruso - 24 gennaio 2025