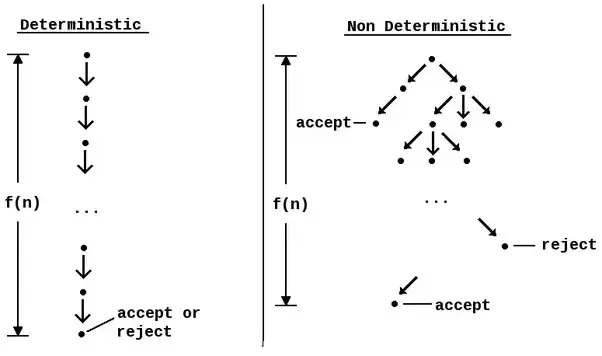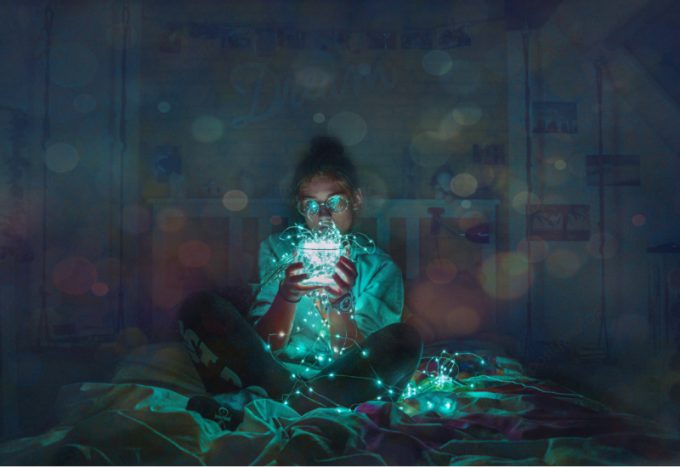I formalismi della logica
quantistica sembrano
rappresentare il modo
di agire delle persone
quando si trovano di
fronte a insicurezza e
ambivalenza
IL PENSIERO QUANTISTICO
Il funzionamento del nostro cervello non è
ancora chiaro fino in fondo. Così gli specialisti
continuano a interrogarsi su come facciamo
di preciso a elaborare le informazioni e a
usarle per prendere decisioni. La questione è ulteriormente
complicata dal fatto che non sempre
il nostro comportamento segue la logica classica.
Ecco un esempio famoso: immaginiamo un
certo Hans che gioca d’azzardo scommettendo
sul lancio di una moneta. Se esce testa vince
200 euro, se esce croce ne perde 100. Se dopo il
primo lancio viene a sapere il risultato, di solito
gioca ancora una volta, che abbia vinto o perso.
Se invece non conosce l’esito del lancio, tendenzialmente
smette di giocare. Questo tipico comportamento
umano è stato descritto per la prima
volta nel 1992 da Amos Tversky ed Eldar Shafir,
rispettivamente della Stanford e della Princeton
University, ed è in contraddizione con la teoria
della probabilità classica.
Secondo questa teoria,
infatti, anche non sapendo se ha vinto o se ha
perso, Hans dovrebbe decidere di lanciare ancora,
perché è proprio ciò che fa se conosce il risultato,
qualunque esso sia.
Gli psicologi si imbatterono in questi modelli
di comportamento «irrazionali» già nella prima
metà del XX secolo. Portano a numerosi famosi
paradossi dell’economia del comportamento,
nei quali di fronte all’incertezza si agisce, erroneamente,
in modo illogico. In effetti però non
sono soltanto questi paradossi, più o meno artefatti,
a essere difficili da spiegare per la scienza.
In fondo ogni decisione si basa su una certa misura
di incertezza.
Semplicemente, non abbiamo risorse mentali
a sufficienza per cogliere allo stesso tempo tutti
gli aspetti di una questione e tenerne conto nelle
nostre riflessioni. A questo proposito gli esperti
parlano di «razionalità limitata». Perciò decidiamo
in base a un’euristica, vale a dire un processo in cui traiamo conclusioni velocemente, basandoci
solo su poche informazioni. E a seconda di
quali analizziamo e della sequenza in cui le consideriamo,
cambia la prospettiva, e infine anche
il nostro comportamento.
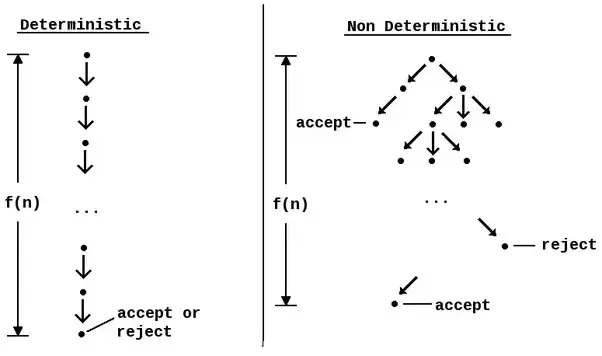
Differenza tra un algoritmo deterministico e uno non deterministico
Una metafora della fluidità del pensiero
Per comprendere questa situazione con i modelli
probabilistici, di tanto in tanto psicologi,
scienziati della cognizione e teorici hanno dovuto
elaborare formalismi matematici complicati.
Di conseguenza esistono molti modelli psicologici
diversi, a volte contraddittori, nessuno dei
quali si può applicare a tutte le situazioni. Perciò
alcuni esperti ritengono la statistica classica inadeguata
a descrivere il comportamento umano e
prevederlo con precisione.
Ipotizzano che invece possa rivelarsi utile a
questo scopo la meccanica quantistica. Per capire
questo ragionamento bisogna fare chiarezza
sulla differenza tra l’immagine del mondo classica
e quella quantistica.
Nella realtà classica, in
un determinato momento un sistema ha un solo
stato. Pensiamo al gatto di Schrödinger nella scatola,
un esperimento concettuale del celebre fisico
Erwin Schrödinger (si veda il box): anche
se non si guarda nel contenitore il gatto è
inequivocabilmente o morto o vivo. In una realtà
quantistica invece si troverebbe in uno stato di
sovrapposizione, cioè in un certo senso è sia vivo
che morto, finché non si apre la scatola per controllare.
È solo in questo momento che – direbbe
un fisico – «collassa la funzione d’onda» che descrive
lo stato del gatto; soltanto adesso l’animale
è effettivamente vivo o morto. In altre parole,
nel mondo dei quanti gli oggetti possono esistere
nel cosiddetto stato di sovrapposizione tra vari
stati possibili.
Negli anni novanta Diederik Aerts, un fisico
belga, è stato il primo a proporre di usare la sovrapposizione quantistica per descrivere il comportamento
umano. Poi la sua idea è stata ripresa
da altri, tra cui i due psicologi Emmanuel
Pothos, della City University di Londra, e Jerome
Busemeyer, dell’Università dell’Indiana a Bloomington.
Ecco la loro spiegazione: le decisioni si
basano su stati indeterminati che contengono le
sensazioni intuitive di conflitto, ambiguità o incertezza.
«La sovrapposizione cattura queste sensazioni
ambivalenti. Non significa che il cervello
sia letteralmente un computer quantistico, come
ipotizzano alcuni fisici. Ma la fisica quantistica è
una metafora utile per rappresentare la fluidità
del pensiero umano»,
ha dichiarato Busemeyer
nel 2012 a «Scientific American».
Quando riflettiamo su diverse opzioni, ne creiamo
una rappresentazione mentale. All’inizio tutte
le possibilità coesistono, e ognuna per così dire
ha una certa probabilità di essere scelta. Questa
situazione corrisponde alla sovrapposizione
quantistica di più stati. Quando poi ci concentriamo
su un’opzione, la funzione d’onda collassa e
all’improvviso le altre possibili scelte per noi non
esistono più.
«In base agli stimoli ambientali su cui ci si concentra,
consapevolmente o no, si ottiene un risultato
o l’altro», spiega Günther Wirsching,
matematico dell’Università Cattolica di Eichstätt-
Ingolstadt.
La situazione somiglia a un esperimento
di misurazione nella meccanica quantistica.
«Se si misura la quantità di moto di una
particella non si conosce più la posizione, e viceversa
» (la quantità di moto è uguale alla massa
per la velocità).
Con il nostro modo di misurare
– che in ultima analisi significa includere nella
decisione alcuni aspetti ed escluderne altri – influenziamo
il risultato. I fisici farebbero grosso
modo questo paragone. I matematici come Wirsching
usano modelli probabilistici della meccanica
quantistica per descrivere questi processi
decisionali:
«Diversamente dalla logica classica
– spiega – quella quantistica è adatta a rappresentare
allo stesso tempo punti di vista o concezioni
differenti» (si veda il box).
Sovrapposizione di vari stati mentali
Che cosa significa tutto ciò in relazione al lancio
della moneta descritto all’inizio? Finché Hans
non prende una decisione, la sua mente si trova
in uno stato che non è né testa né croce, bensì di
sovrapposizione, come scritto nel 2023 sulla rivista
«Scientific Reports» da Dorje C. Brody, matematico
britannico dell’Università del Surrey.
Nella meccanica quantistica infatti si parte dal
presupposto che il lancio porti contemporaneamente
a vincere e a perdere (in altre parole: il gatto
di Schrödinger è sia vivo che morto). In quello
stato ambivalente di sovrapposizione, la decisione
definitiva di Hans è effettivamente imprevedibile.
Secondo la logica quantistica, però, adesso
l’informazione sull’esito dell’esperimento precedente
può interagire con la funzione d’onda in
modo che questa tenda a collassare verso il «sì»,
cioè la decisione di giocare ancora. L’informazione
di per sé, cioè il fatto di avere vinto o perso,
non è determinante.
Un altro esempio è un noto esperimento di teoria
dei giochi: il dilemma del prigioniero. Qui un ipotetico detenuto può scegliere se cooperare
con il suo complice, non confessando il loro crimine,
oppure vuotare il sacco con la polizia. Se
entrambi confessano, ciascuno riceve una pena
di quattro anni. Se entrambi tacciono, sono condannati
a due anni. Se invece solo uno confessa
e l’altro tace, il primo evita la pena e il secondo è
condannato a cinque anni.
Se i partecipanti vengono a sapere che il loro
complice ha «cantato», per la maggior parte scelgono
a loro volta di confessare. Se invece questo
ha tenuto la bocca chiusa, la maggioranza sceglie
ciononostante di vuotare il sacco (e quindi cavarsela
senza condanna). È un comportamento che
ci si può aspettare se si presuppone che ciascuno
agisca nel proprio interesse. Ma c’è qualcosa di
strano: se ai partecipanti non si comunica la decisione
del complice, la maggior parte tace.
Zheng Joyce Wang, esperta di scienze cognitive
dell’Ohio State University, ha dato alla rivista
«The Atlantic» una spiegazione ad sensum dalla
prospettiva quantistica, nei seguenti termini: il
prigioniero immagina che il complice possa tacere
o tradirlo. Ciascuna di queste possibilità è come
un’onda del pensiero. E come qualsiasi onda
– per esempio di luce, suono, acqua – anche queste
si possono disturbare o addirittura cancellare
reciprocamente. Per esempio, le due tendenze
del giocatore – sia confessare se il complice parla,
sia farlo anche quando tace – possono compensarsi
a vicenda, se deve destreggiarsi con entrambe
le opzioni in testa. Se però nella mente di
un giocatore si rafforza l’onda del pensiero «l’altro
collaborerà», potrebbe decidere di confessare
a sua volta.
La sequenza è decisiva
Nella teoria della probabilità classica, inoltre,
le risposte a più domande non dipendono dalla
loro sequenza. Eppure la realtà sembra diversa.
In uno studio pubblicato oltre vent’anni fa, ad alcuni
volontari è stato chiesto se ritenessero onesto
Bill Clinton, all’epoca presidente degli Stati
Uniti. Poi hanno dovuto valutare se lo fosse il
suo vice Al Gore. Alla domanda su Clinton circa il
50 per cento ha risposto «sì», mentre per Gore il
«sì» ha raggiunto circa il 60 per cento. Con le domande
nell’ordine inverso i numeri sono cambiati:
il 68 per cento di «sì» per Gore e il 60 per cento
per Clinton.
Anche nella meccanica quantistica i risultati
possono essere influenzati in modo decisivo dalla
sequenza degli esperimenti. Per esempio, se si
misura la posizione di una particella e poi la sua
quantità di moto, i risultati sono diversi da quelli
ottenuti misurando prima la quantità di moto
e poi la posizione. Si tratta delle cosiddette osservabili
complementari. Si basano sul principio
della complementarità, introdotto dal fisico
Niels Bohr nel 1928 per avvicinarsi al dualismo
onda-particella: due osservazioni di un fenomeno
eseguite con metodi diversi si escludono reciprocamente,
ma sono comunque associate e si
completano a vicenda. Quindi se si osservano le
proprietà ondulatorie, quelle corpuscolari scompaiono.
Vale altrettanto per la quantità di moto e
la posizione di una particella: se si misura esattamente
una delle due grandezze, l’altra non si può
più misurare con precisione.
Nel 2015 Busemeyer e Wang hanno spiegato
che cosa significa questo principio se si estende
alla presa di decisioni:
«Si ha una complementarità
quando una persona non riesce ad assumere
allo stesso tempo una posizione ben definita
su entrambi i politici. Si può misurare l’“onestà”
di Clinton o Gore, ma non di tutti e due contemporaneamente.
L’ordine della misurazione a sua
volta influenza le risposte». Il motivo è che la risposta
alla prima domanda (Clinton è onesto?)
crea un contesto che modifica la risposta alla seconda
(Gore è onesto?). Nella logica quantistica la
conseguenza di questa incompatibilità è che una
persona sicura della risposta a una domanda può
essere incerta sulla risposta all’altra.
Il cervello, un computer quantistico?
«Se un modello matematico descrive bene i risultati,
dietro di esso possono nascondersi strutture
assolutamente concrete che si comportano
in quel modo», afferma Wirsching. Perciò non
escluderebbe del tutto che nel cervello, a livello
microscopico, si verifichino anche effetti quantistici.
«Non lo sappiamo, ed è incredibilmente difficile
verificarlo».
L’esistenza nel cervello di fenomeni che ricordano
quelli della fisica quantistica è stata dimostrata
dal fisico e neuroinformatico Peter beim
Graben. All’inizio del secolo si è posto questa domanda,
tuttora oggetto delle sue ricerche: «Come
si possono collegare le descrizioni del cervello ricavate
da misurazioni approssimative come un
EEG con i processi che avvengono a livello microscopico
nei neuroni?». All’epoca la sua idea
era che qui potesse esistere una complementarità
come, nella meccanica quantistica.
Insieme con il fisico tedesco Harald Atmanspacher,
Beim Graben ha elaborato una teoria
che applica questo principio alle misurazioni del
cervello: da un lato le onde cerebrali attraverso le
elettroencefalografie, dall’altro le risonanze magnetiche
basate sulle proprietà dei nuclei atomici
nel cervello, in un’ulteriore contrapposizione tra
onde e particelle. «Abbiamo dimostrato che il formalismo
della complementarità è adatto a descrivere
il rapporto tra misurazioni macroscopiche
e processi a livello microscopico», spiega Beim Graben. Hanno definito il loro metodo «quantizzazione
epistemica» (dal greco antico epistéme,
ossia scienza, conoscenza).
Inizialmente non esisteva una relazione chiara
con i processi cognitivi autentici e il comportamento
umano. A stabilirla per primo è stato il
fisico teorico e linguista Reinhard Blutner, che
insieme con beim Graben nel 2015 ha avuto l’idea
di applicare la quantizzazione epistemica alla
razionalità limitata. «Partendo dalle risorse mentali
limitate di cui disponiamo si può elaborare
un formalismo che finisce nella rappresentazione
della quantizzazione epistemica». Ed ecco che
all’improvviso, con questo costrutto matematico
proveniente dalla meccanica quantistica, è stato
possibile risolvere i problemi fondamentali della
psicologia e delle scienze cognitive descritti in
precedenza.
L’espressione a effetto è poco efficace
All’epoca il settore di ricerca della cognizione
quantistica era ancora relativamente nuovo. Peter
Beim Graben ricorda che nel 2009 si è svolto
ad Amsterdam un congresso sulla psicologia
matematica. Erano presenti anche molti altri colleghi
attivi nella ricerca sulla logica quantistica.
«Abbiamo discusso a lungo su come chiamare
questo nuovo settore di ricerca». Alla fine si è
scelto «cognizione quantistica»: secondo Beim
Graben si tratta di «un’espressione a effetto».
Eppure il presunto nome accattivante non ha
portato a questo settore di ricerca il riconoscimento
sperato. In tutto il mondo sono una ventina
o poco più gli scienziati che se ne occupano,
mentre in Germania si contano sulle dita di una
mano. «Le relative ricerche hanno buone citazioni
», commenta beim Graben. Tuttavia, per esperienza
personale con le candidature di lavoro sa
che nelle scienze cognitive si preferisce ancora
la statistica classica. Wirsching prova a ipotizzare
una spiegazione: «Finché si considera il mondo
solo da una prospettiva materialista, cioè osservando
solo gli atomi, le molecole e i processi
biochimici su cui si basa, arrivare alla cognizione
quantistica è pressoché impossibile».
Incredibile varietà di applicazioni
Nonostante la scarsa considerazione nella comunità
della ricerca, la cognizione quantistica
ha un’incredibile varietà di possibili impieghi.
Beim Graben e Blutner per esempio hanno
dimostrato che si può usare per comprendere i
risultati di esperimenti di psicologia musicale,
scoprendo perché il nostro udito trovi alcuni abbinamenti
di toni più gradevoli di altri. In questi
esperimenti i volontari hanno ascoltato un cosiddetto
contesto di priming, come una scala o
un accordo che fissa una tonalità, per esempio
do maggiore, seguito da un tono scelto casualmente
tra i dodici livelli della scala cromatica.
Quindi hanno dovuto valutare quanto fosse gradevole
il tono abbinato al contesto di priming. In
questo contesto la nota ritenuta più adatta è stata
il do (la tonica), seguita dagli altri due componenti
della triade di do maggiore, cioè sol (la
dominante) e mi (la mediante). «Partendo dal circolo
delle quinte abbiamo sviluppato le descrizioni
della funzione d’onda per lo spazio tonale
sottostante», racconta Beim Graben. Alla fine ne
è risultata una descrizione dello stato strutturata
come l’equazione di Schrödinger, su cui si basa la
meccanica quantistica.
Inoltre, può darsi che la cognizione quantistica
sia utilizzabile per applicazioni di intelligenza
artificiale (IA). A questo scopo si stanno eseguendo
ricerche, per esempio, nel gruppo di lavoro di
Matthias Wolff alla Brandenburgische Technische
Universität di Cottbus–Senftenberg, con cui
collaborano anche Peter Graben e Günther
Wirsching. «Per l’IA finora si sono usate principalmente
le reti neurali profonde. Il problema è
che in realtà non si sa assolutamente quali rappresentazioni
interne si formano negli strati più
profondi», spiega beim Graben. Perciò a volte gli
algoritmi non sono per niente trasparenti e non è chiaro come faccia l’intelligenza artificiale a sviluppare
le proprie capacità.
Se si abbinassero i formalismi della cognizione
quantistica con i modelli di IA tradizionali – spiega
beim Graben – i sistemi potrebbero diventare
più trasparenti. E aggiunge: «Le strutture matematiche
della teoria quantistica si possono interpretare
». Per esempio, le attività delle reti neurali
artificiali avrebbero in qualsiasi momento una
rappresentazione simbolica – un significato – che
sarebbe leggibile.
Un ulteriore vantaggio degli algoritmi basati
sulla logica quantistica è che apprendono più
velocemente delle reti neurali classiche. Wirsching spiega che il motivo è la natura matematica
di questi sistemi: «Partendo da un contesto
formulato nel linguaggio della logica quantistica,
per alcune domande servono molti dati di addestramento
in meno che per il training di una rete
neurale». Perciò immagina una combinazione dei
due approcci. Per esempio, usando molte migliaia
di immagini facilmente disponibili sarebbe relativamente
facile addestrare una rete neurale a riconoscere
le foglie. Così però l’IA non sa ancora distinguere
le foglie di piante diverse».
Per esempio: è una foglia di quercia o di faggio?
Secondo Wirsching, basterebbero pochissimi
esempi per trasmettere questa capacità ai programmi di IA basati sulla logica quantistica.
Infine, i sistemi di IA attuali assumono una sola
prospettiva, mentre le persone ne hanno molte e
devono sceglierne una. «Con la cognizione quantistica
potremmo configurare l’IA in modo che sia
in grado di scegliere le prospettive», spiega
Graben. In un certo senso si inserirebbe nei sistemi
la razionalità limitata. «Allora l’agente IA
avrebbe un ordine delle preferenze, che però potrebbe
cambiare». In questo modo si potrebbero
innescare nell’IA motivazioni ed esigenze: «Così,
rispetto ai sistemi di IA precedenti, avrebbero un
modo di pensare e agire molto più simile qualitativamente
a quello umano ».
Janosch Deeg
è dottore di ricerca
in fisica e lavora a
Heidelberg come
giornalista scientifico
La matematica alla base
della cognizione quantistica
Günther Wirsching e altri descrivono il comportamento umano
con un concetto matematico proveniente dalla fisica quantistica:
si può rappresentare l’insieme delle decisioni possibili sotto forma
di vettori in uno spazio di Hilbert unitario (una determinata specie
di spazio vettoriale con prodotto scalare). «Con questo costrutto
matematico, in origine elaborato per la fisica quantistica, si possono
realizzare modelli delle opzioni decisionali e del processo con cui ci
si concentra su un aspetto tra molti, e infine calcolare le probabilità
di un determinato comportamento», spiega Wirsching. «E c’è una
buona corrispondenza dei valori con i risultati degli esperimenti di
psicologia comportamentale».

Il gatto di Schrödinger
Nel 1935 Erwin Schrödinger propose un esperimento concettuale
apparentemente paradossale. Prendete un gatto e chiudetelo
in una scatola. Inseritevi inoltre una bottiglietta di veleno e un
elemento radioattivo. Un contatore Geiger rileva se il nucleo
atomico decade, e in questo caso attiva un meccanismo che
rilascia il veleno mortale. L’esperimento sembra crudele, ma
serve solo a spiegare un dilemma fondamentale della teoria
quantistica, con il quale il fisico teorico austriaco voleva dimostrare
la sua incompletezza. Il problema: secondo le leggi della teoria
quantistica, il nucleo dell’atomo radioattivo inizialmente si trova
in uno stato di sovrapposizione tra «decaduto e non decaduto».
Se quelle leggi valessero anche per gli oggetti macroscopici,
come un gatto, questo dovrebbe trovarsi a sua volta in uno stato
di sovrapposizione, cioè «tra vivo e morto». In una fase di questo
tipo, per l’atomo e il gatto si possono fare soltanto affermazioni
probabilistiche.
È solo quando si apre la scatola (al momento dell’osservazione
o misurazione) che avviene un cambiamento drammatico. A
questo punto l’atomo rivela uno dei due stati, «decaduto» o «non
decaduto», e quindi il gatto si dimostra rispettivamente «morto»
o «vivo». O almeno è così che l’interpretazione di Copenaghen,
sostenuta dalla maggior parte dei fisici, spiega questi bizzarri
fenomeni quantistici. La causa postulata da questa interpretazione
è un «collasso della funzione d’onda», cioè una riduzione da uno
stato misto di sovrapposizione a uno univoco.

L'interpretazione della meccanica quantistica è il tentativo di definire un quadro coerente delle informazioni che la meccanica quantistica fornisce sugli elementi di realtà del mondo fisico elementare.
Infatti, nonostante la teoria sia stata estensivamente verificata sperimentalmente, alcuni suoi aspetti lasciano spazio a diverse interpretazioni che si differenziano per il significato della funzione d'onda (significato ontico o epistemico e completezza) e per alcuni aspetti riguardanti il determinismo, il realismo, la violazione della località, l'esistenza della funzione d'onda universale, il collasso della funzione d'onda, il ruolo dell'osservatore.
L'argomento è di interesse soprattutto per i filosofi della fisica, ma anche per i fondamenti della disciplina, poiché sulle nuove frontiere della fisica si gioca anche il concetto stesso di ontologia, che si va sempre più configurando come un'ontologia fisica. Molti sono infatti oggi i fisici che fanno filosofia e i filosofi che si occupano di fisica, alimentando un dibattito vivissimo per le questioni onto-fisiche.
Riporto questo articolo per pura curiosità.
Il pensiero influenza la realtà: fisica quantistica applicata alla mente
di Francesca Tozzi
Secondo la fisica quantistica tutti noi siamo parte di una realtà che creiamo man mano che la osserviamo. Per questo possiamo modificarla.
Paolo Scarpari, fisico quantistico, ci spiega come
Se già il filosofo Immanuel Kant sosteneva che è la mente che modella la realtà attraverso le forme tramite cui la percepisce, c’è da chiedersi: perché continuiamo a considerare il reale come qualcosa di estraneo a noi e, ancora, potremmo avere un ruolo nel produrlo? In questa direzione va la fisica quantistica, considerata ancora una teoria, sebbene, fra tutte le teorie alternative sulla realtà, sia quella che fornisce maggiori possibilità di comprensione dell’esistenza.
Per chiarirci le idee abbiamo incontrato, all’ultima edizione di SaporBio, Paolo Scarpari, Life and Business Coach, studioso dei processi di determinazione e di sviluppo della realtà, il cui sistema di pensiero apre notevoli spazi alle possibilità umane di operare un cambiamento attraverso un cambio di paradigma.

L’atto di una persona che osserva la realtà determina l’attivazione di quello sul quale è focalizzata: in altri termini, di quello che pensa o si aspetta di vedere
Quando nasce tutto questo?
Nel 1909 con i primi esperimenti sul comportamento dei fotoni svolti in un laboratorio di fisica da Geoffrey Ingram Taylor. Proiettate contro una barriera con due fori, le particelle, invece di transitare per i due fori una alla volta li attraversarono simultaneamente, cosa che non rispondeva alle attese della fisica tradizionale: si comportarono cioè come se sapessero ciò che sapeva solo lo scienziato che conduceva l’esperimento. La conclusione fu che l’osservatore aveva influenzato la particella attraverso il semplice fatto di essere presente all’esperimento. L’informazione presente in lui aveva fornito le istruzioni della nuova forma da assumere dovendo muoversi in presenza di due fenditure.
Questo esperimento, ripetuto nel 1998 presso il Weizmann Institute di Israele con apparecchiature più sofisticate e sensibili, confermò il risultato dimostrando inoltre che più le particelle venivano osservate, più erano influenzate dall’osservatore.
In sintesi, l’esperimento significa che la realtà è la risultanza fra osservatore ed osservato. Secondo l’interpretazione elaborata nel 1927 da Niels Bohr e Werner Heisenberg, ambedue Premi Nobel per la Fisica rispettivamente nel 1922 e 1932, nota come l’Interpretazione di Copenaghen, l’universo esiste in quanto numero infinito di possibilità sovrapposte tutte presenti contemporaneamente come possibili. L’atto di una persona che osserva quei potenziali determina l’attivazione di quello sul quale è focalizzata: in altri termini, quello che pensa o si aspetta di vedere.
Cosa impedisce una completa accettazione di teorie che sono già state valorizzate ampiamente dalla comunità scientifica?
Sono teorie destabilizzanti, abituati come siamo a pensare a una realtà esterna e indipendente da noi. Nonostante questo pensiero affondi le radici nelle antichissime culture orientali, che consideravano la realtà come Maya (in sanscrito “illusione”), sono passati solo cento anni da quelle prime scoperte e, probabilmente, serviranno alcune generazioni affinché questo cambio di paradigma entri nella coscienza collettiva.
Oggi, anche la fisica quantistica afferma che la realtà è un’illusione. Le implicazioni di quanto detto sono notevoli: siamo parte di una realtà che creiamo man mano che la osserviamo. A partire dal lavoro del neurochirurgo Karl Pribran, si è studiata l’attività del cervello in termini olografici, ovvero l’ipotesi che il nostro cervello processi la realtà come se fosse un ologramma: come la luce laser attiva una memoria statica che prende forma, così noi, che siamo un insieme di cellule che emette energia, osservando e pensando attiviamo l’ologramma del reale, ovvero le memorie presenti non solo nel nostro campo morfogenetico personale, bensì anche quelle registrate nel più ampio campo elettromagnetico di cui siamo parte.
E questo cosa implica nel quotidiano di ognuno di noi?
Dal fatto che quello che vedo lo sto costruendo nel mio cervello consegue che non c’è realtà su cui non si possa intervenire: attraverso il mio pensiero, che è il laser che fa emergere l’ologramma, io posso cambiare la realtà. Un’esperienza comune è quella di pensare intensamente a qualcosa che poi accade: visualizzare un parcheggio e focalizzarci su dei posti liberi che poi troveremo o immaginare nel dettaglio una serata con un certo tipo di ambiente e persone e trovare poi una situazione molto simile nella realtà. Chi la prova, sperimenta il potere dell’immaginazione capace di creare un pezzo di realtà che poi si ripresenta fuori.
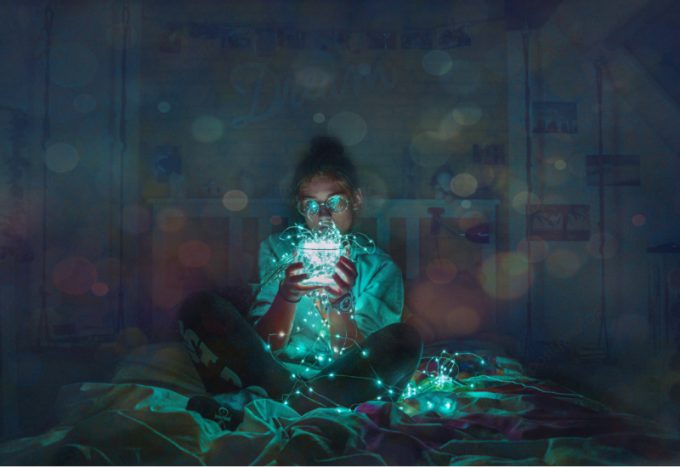
Il mondo che osserviamo esterno a noi è il riflesso di ciò che, inconsapevolmente, processiamo a livello del subconscio e dell’inconscio collettivo
Perché allora la realtà non corrisponde sempre a come vorremmo che fosse?
Perché il cervello, attraverso i suoi diversi campi elettrici detti “stati mentali”, elabora i dati e crea ciò che percepiamo come realtà a diverse velocità: Beta per elaborare principalmente il piano cosiddetto esterno-oggettivo e il pensiero razionale, Alfa per elaborare principalmente i piani più interiori, incluso l’emozionale e il mentale inferiore, Theta per elaborare principalmente il subconscio, la parte dell’inconscio collettivo alla quale, consapevolmente e non, abbiamo aderito, determinando ciò che percepiamo come il nostro senso di esistere, Delta per elaborare principalmente l’inconscio collettivo, Gamma per elaborare principalmente la realtà multidimensionale. Al momento si suppone che Theta–Delta elabori la realtà 500.000/1.000.000 di volte più veloce di Beta. Ciò significa che il nostro conscio è troppo lento per accorgersene e, per questo, essendone inconsapevole, lo chiamiamo inconscio, nel senso che è a lui sconosciuto. Per quanto ne sappiamo il conscio rappresenta solo il 10/15 percento dell’elaborazione, per cui non siamo consapevoli di ciò che stiamo elaborando realmente.
E quindi?
Noi creiamo la realtà in riflesso al sentimento profondo che abbiamo di noi stessi. Ciò significa che il mondo che osserviamo esterno a noi è il riflesso di ciò che, inconsapevolmente, processiamo a livello del subconscio e dell’inconscio collettivo. Non corrisponde a ciò che desideriamo a livello del conscio poiché influisce in minima parte. Per questo crearci una realtà come il trovare un parcheggio e passare una serata gratificante è più facile che cambiare realtà più complesse come il lavoro e il rapporto con il partner.
Le prime situazioni sono gestite a livello completamente conscio ma se io, pur desiderando guadagnare molti più soldi, ho radicata in me la convinzione che fare soldi è una cosa sporca, se desidero una promozione ma ho instillato in me l’idea di non potercela fare mai, se cerco il colpo di fortuna ma mi sento perseguitato dalla sfortuna, nulla potrà il mio desiderio elaborato in Beta se Alfa e Theta si stanno muovendo in direzione contraria. Sciogliere il velo di separazione tra questi diversi aspetti dell’elaborazione di noi stessi e del mondo rappresenta l’unica via per creare volontariamente e consapevolmente il mondo, la vita e il noi che vorremmo essere.
E come si fa?
Si possono fare vari tentativi. Per le cose più semplici può essere sufficiente la visualizzazione, perché mentre il pensiero si focalizza su una situazione immaginata si attivano dei processi anche in Alfa e Theta. Un altro sistema è lavorare, ad esempio, sul retro pensiero a livello del subconscio: attraverso tecniche di meditazione, di rilassamento profondo e di mind control si possono attivare gli stati di Alfa e Theta rimanendo vigili per orientare consapevolmente il subconscio verso la direzione desiderata.
Questo tipo di meccanismi sono alla base della teoria che la qualità del pensiero determini la qualità delle situazioni che attiriamo. La scienza stessa ha dimostrato che pensare spesso in negativo può indebolire il sistema immunitario: pensare in continuazione “sto per ammalarmi” attiva nel cervello l’emissione di neuropeptidi, informazioni chimiche inviate a tutte le cellule, che metteno in moto meccanismi di allerta, determinando già una situazione di debolezza e disagio nell’organismo. La convinzione di essere malato porta già a cominciare a esserlo. Così accade con il pensiero “sono sfortunato, la gente non mi ama, non ce la farò mai” che tenderà sempre a creare situazioni negative, di rifiuto e delusione.
Eugenio Caruso - 8 aprile 2025

Il fiore di girasole, logo del sito, unisce natura, matematica e filosofia.