Per circa un decennio la grotta di Denisova in Siberia è stata l’unica dimora
conosciuta di un’enigmatica popolazione contemporanea dei
Neanderthal. I Denisoviani, appunto. Più recentemente è venuta alla
ribalta una seconda casa, potenzialmente più generosa di resti fossili e
forse ancora più suggestiva. La grotta di Baishiya è incastonata nell’altopiano
tibetano, una vasta distesa che dall’Himalaya arriva fin dentro al cuore della Cina
Per ammirare il paesaggio mozzafiato che si spalanca davanti
a questa cavità occorre salire di quota fino a 3281 metri. La spiritualità
si respira insieme all’aria sottile, in questo luogo sacro per i
buddhisti e ormai anche per antropologi e archeologi, animato da
scavi e campionamenti, riti e meditazioni.
«Le bandierine colorate davanti all’ingresso sono quelle tipiche
del buddhismo. Ci sono sei parole scritte sopra. Il vento le
muove ed è come se le sussurrasse di continuo, è una forma di
preghiera», ci dice Dongju Zhang, dell’Università di Lanzhou, che
con il suo gruppo di studenti laureati e postdoc da cinque anni sale
fin lassù per studiare le tracce lasciate dagli antichi abitanti della
grotta. «Non sappiamo che cosa pensino i monaci del nostro lavoro,
alcuni hanno espresso sorpresa».

Alcuni manufatti trovati nella grotta di Denisova e analizzati, si distinguono ossa appuntite e denti perforati
I ricercatori preferiscono scavare d’inverno, quando il freddo
scoraggia i visitatori, anche se portare su e giù attrezzatura e materiali
ogni giorno è faticoso, e a quell’altitudine bisogna fermarsi
a prendere fiato. Entrando di mattina nella bocca della grotta,
larga otto metri e alta cinque, i primi passi sono illuminati dal sole,
poi senza le luci artificiali sarebbe buio fitto per centinaia di
metri. Il gruppo ha da poco iniziato a scavare una nuova unità e
continuerà a lavorarci nei prossimi due anni, le aspettative sono
elevate.
«Non c’è dubbio che questo sito ci regalerà molte altre
scoperte»,
confida Frido Welker, che nel 2019, quando era dottorando
al Max-Planck-Institut di Lipsia, ha contribuito a interpretare
il primo reperto proveniente da Baishiya e ora insegna all’Università
di Copenaghen, continuando a collaborare con Zhang.

Ingresso della grotta di Denisova
Mentre lo studio dell’evoluzione umana fiorisce in Cina, in
Siberia le attività di ricerca scientifica soffrono le conseguenze
della guerra. La rivista
«Nature» recentemente ha descritto gli effetti delle sanzioni:
le collaborazioni scientifiche internazionali sono scoraggiate, se
non del tutto impedite, mandare i campioni all’estero è diventata
un’impresa e probabilmente scarseggiano anche i reagenti per
le analisi più avanzate. Nonostante le difficoltà attuali, comunque,
la grotta situata sul massiccio dell’Altaj resterà per sempre
centrale nella mappa degli studi denisoviani, e non solo per il nome.
Questo sito rappresenta lo scrigno molecolare da cui nel 2010
è emerso il primo genoma completo di questo gruppo umano di
cui non si sospettava nemmeno l’esistenza (una scoperta enorme,
fatta a partire dal frammento del mignolo fossile di una ragazzina
sui 12-13 anni di età). Inoltre è l’unico luogo al mondo che sappiamo
essere stato abitato nel corso dei millenni anche da neanderthaliani
e Sapiens, dunque ci appare come un crocevia di popoli e
culture paleolitiche.
Fra i ritrovamenti più eccezionali che ci ha regalato c’è il
genoma recuperato da una scheggia d’osso lungo, che è risultato
appartenere a una ragazzina meticcia, figlia di padre
neanderthaliano e madre denisoviana, a riprova del fatto che gli
antichi incontri non sono stati platonici. Il sito di Denisova detiene
anche il record del DNA nucleare umano più antico mai
sequenziato, estratto da un molare denisoviano vecchio 200.000
anni. Finora però, purtroppo, questo posto così magico per la
conservazione delle molecole ci ha restituito solo fossili decisamente
frammentari, cosicché abbiamo imparato a conoscere
«gli umani del terzo tipo» prima dal punto di vista genetico che
da quello morfologico. Tutto il contrario di quello che è accaduto
con Neanderthal, il cui primo fossile è venuto alla luce nel lontano
1856, un secolo e mezzo prima del primo genoma neanderthaliano
completo.
È in Cina, dunque, che la misteriosa popolazione emersa
inaspettatamente in Siberia sta finalmente trovando un volto,
un corpo e anche un posto di rilievo nella grande avventura dell’evoluzione
umana. Se il labirinto a tre camere dell’antro di Denisova
ha creato il rebus, possiamo dire che è nelle viscere di Baishiya
che sta prendendo forma la soluzione.
«Il primo indizio è la mezza mandibola di Xiahe, chiamata così
dal nome della città omonima dove sorge il monastero di
Labrang, il più importante centro del buddhismo tibetano fuori
dalla regione autonoma del Tibet»,
dice Silvana Condemi, coautrice
insieme a François Savatier del libro L’enigma Denisova. Dopo Neandertal e Sapiens, la scoperta di una nuova umanità, appena
uscito con Bollati Boringhieri. A trovare questo fossile nella
vicina grotta di Baishiya, nel 1980, è stato proprio un monaco,
che ha voluto portarlo in dono al «Sesto Buddha vivente di Gung-
Thang». Molti antichi resti in passato sono finiti triturati in qualche
medicamento tradizionale. Per fortuna il maestro spirituale
ha deciso di conservare lo strano fossile e poi consegnarlo a un
geologo dell’Università di Lanzhou. Lì è rimasto, quasi dimenticato,
finché nell’estate del 2016 Dongju Zhang non ha preso contatto
con Lipsia, la capitale mondiale degli studi sul paleo-DNA, dove
il padre della disciplina Svante Pääbo si è guadagnato il Nobel per
il sequenziamento dei primi genomi arcaici.
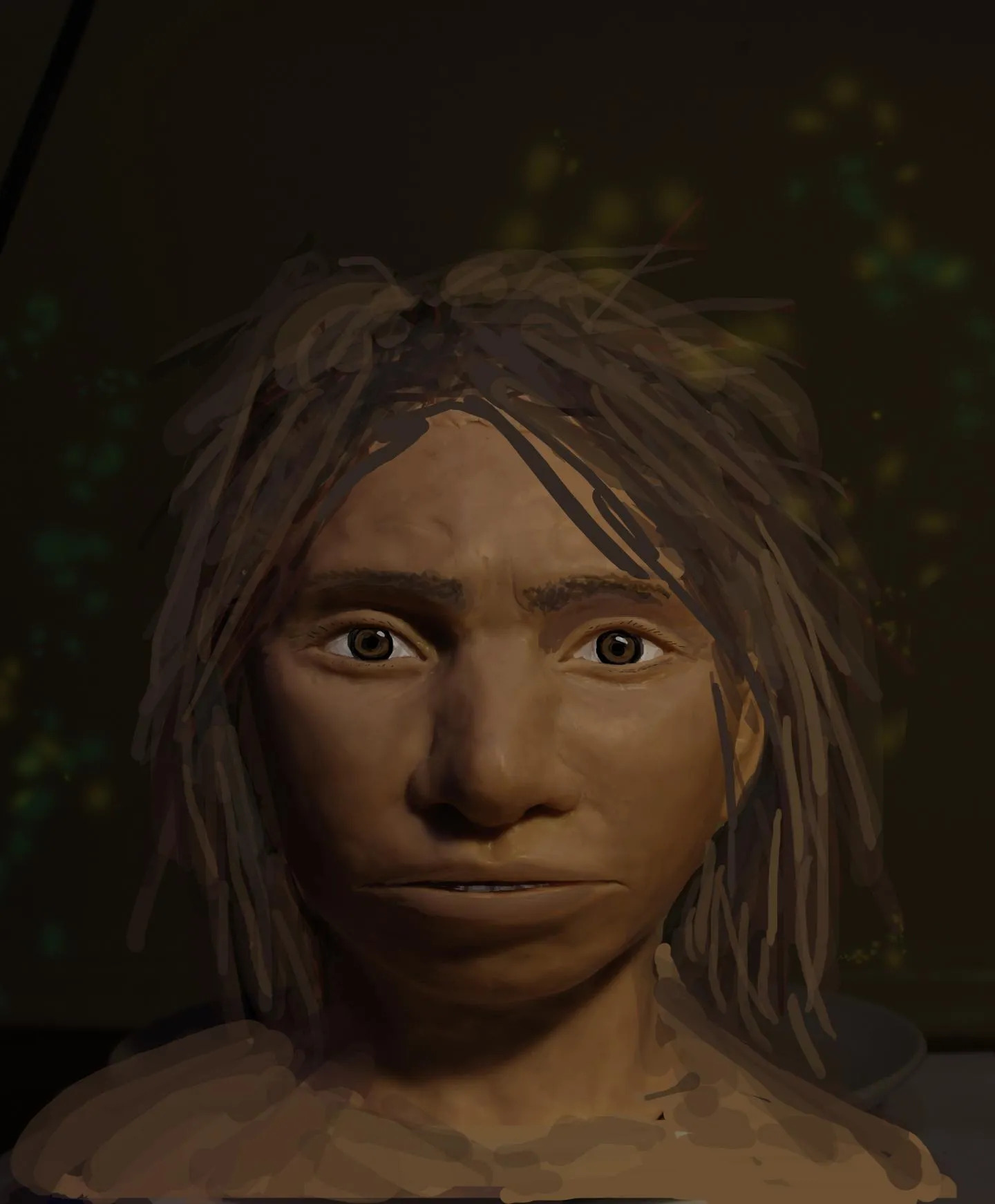
Immagine ipotetica di denisoviano
L’archeologa cinese ha mostrato alcune foto del reperto a
Welker e a Jean-Jacques Hublin del Max-Planck-Institut, che ricorda
così le sue prime impressioni:
«Il fossile era chiaramente
non Sapiens. Era molto robusto, privo di mento e con denti enormi
».
La matrice calcarea incrostata intorno alla mandibola ha consentito
di impiegare la tecnica della radiometria uranio-torio,
datandola intorno a 160.000 anni fa. Un’epoca in cui in Europa
dominava Neanderthal mentre, a causa di una strana asimmetria
concettuale, si pensava che l’Asia fosse ancora popolata da una specie uscita dall’Africa molto tempo prima: l'Homo erectus.
«Col senno di poi non aveva molto senso pensare che in un
continente gli ominidi più antichi si fossero evoluti in una nuova
specie, mentre nell’altro l’evoluzione si fosse fermata allo stadio
precedente»,
ragiona Condemi, che è direttrice di ricerca al
CNRS presso l’Università di Aix-Marseille, in Francia. Oggi si tende
a pensare che mentre in Europa procedeva la neanderthalizzazione,
in Asia andasse in scena un fenomeno analogo, la denisovizzazione.
E allora, la mandibola di Xiahe era forse denisoviana?
Possibile che ci fossero resti etichettabili così a 2000 chilometri di
distanza dall’unico sito conosciuto, quello siberiano? La risposta
arriverà dai dati di genomica, paleogenomica e paleoproteomica.
Il secondo indizio, in effetti, è custodito nel patrimonio genetico
degli uomini e delle donne che oggi abitano alcune regioni
dell’Asia e alcune isole del Pacifico. Quando la prima sequenza
completa di DNA denisoviano è stata pubblicata, 15 anni fa, le analisi
di bioinformatica hanno trovato cospicue tracce genetiche simil-denisoviane in Papua Nuova Guinea, dove in media il 3-6 per
cento del genoma degli abitanti somiglia a quello estratto dal microfossile
che ha rivelato l’esistenza del gruppo arcaico di Denisova.
Gli appassionati di paleogenomica ricorderanno che quella del 2010 era stata una scoperta clamorosa. Pochi millimetri di osso,
corrispondenti alla punta di un dito, erano bastati a Pääbo e a David
Reich, della Harvard University, per scoprire l’esistenza genetica
di una popolazione mai documentata attraverso fossili o resti
archeologici. Appartenevano a una ragazzina vissuta tra 60.000
e 80.000 anni fa, di cui non era rimasta che quella falange miracolosamente
provvista di DNA ben conservato con l’aiuto del gelo
siberiano.
«Per antropologi e archeologi fu uno shock: i genetisti
avevano appena trovato le prove che Neanderthal e Sapiens si
sono incrociati, e adesso pretendevano di aver scoperto dal nulla
una nuova popolazione, forse addirittura una nuova specie umana?
»,
ci dice Condemi.
La presenza di geni di tipo denisoviano in persone che oggi
vivono lontanissimo dai Monti Altaj suggeriva che un tempo
i Denisoviani avessero occupato una regione assai estesa. Dovevano
aver svolto un ruolo da protagonisti, non da semplici comparse del Paleolitico, rappresentando l’equivalente asiatico dei
Neanderthal europei. E come loro dovevano essersi incrociati in
più occasioni con i Sapiens che avevano incontrato lungo il cammino,
lasciando loro in eredità alcune peculiarità genetiche.
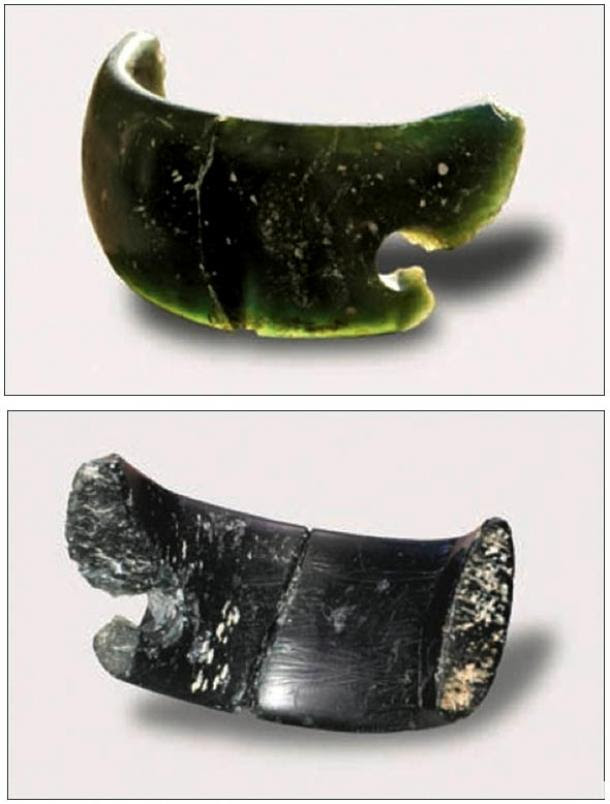
Il bracciale è stato trovato nella regione degli Altai, in Siberia, nel 2008. Gli archeologi e i ricercatori russi lo hanno accuratamente esaminato prima di affermare la sua straordinaria antichità. Lo splendido bracciale venne forgiato dai Denisoviani con tecniche avanzatissime per l'epoca. Alla luce del sole, l'oggetto ne riflette i raggi.
Oggi,
in effetti, si ipotizzano almeno tre ondate di ibridazione.
Il fatto che il peso del contributo denisoviano vari tanto tra le
popolazioni moderne può destare stupore. Per esempio, è molto
ridotto nella principale etnia cinese (Han), quasi nullo nelle Filippine
(con l’eccezione di un gruppo di cacciatori-raccoglitori),
ma alto in Nuova Guinea e a Vanuatu. Probabilmente la spiegazione
va ricercata nella mutevole geografia delle terre emerse, che
ha risentito fortemente dell’effetto delle glaciazioni, mettendo
in contatto le comunità umane in un supercontinente detto della
Sonda, e poi separandole nuovamente nei periodi caldi. Un ruolo
può averlo avuto anche la selezione naturale, che ha premiato
certi tratti denisoviani soltanto in alcuni ambienti. Per esempio si ipotizza che alcuni adattamenti immunitari arcaici siano risultati
utili a Homo sapiens per difendersi dagli agenti patogeni diffusi
nelle umide foreste equatoriali.
Un elemento in particolare salta agli occhi: pur abitando a soli
700 metri di quota, la celebre ragazzina della grotta di Denisova,
quella del mignolo, aveva la versione di un gene (allele EPAS1) importante
per vivere bene in alta montagna, perché aiuta i globuli
rossi a usare in modo efficiente l’ossigeno. Quell’adattamento doveva
essere stato selezionato altrove, tra genti abituate a muoversi
a quote elevate, come l’altopiano del Tibet, che misura mediamente
4500 metri di altitudine. È forte la tentazione di concludere che
siano stati proprio gli antenati dei Denisoviani a sviluppare questo
tratto da super-atleti e che poi sia stato trasmesso per incrocio ai
Sapiens arrivati in questa regione della Cina.
Torniamo dunque alla mandibola di Xiahe e alle ricerche eseguite
per assegnarle un’identità. Se questa parte dell’Asia era
stata al centro del mondo denisoviano perduto, il fossile in teoria
poteva appartenere a questo gruppo, ma come era possibile dimostrarlo?
L’Istituto di paleontologia dei vertebrati e di paleoantropologia
dell’Accademia delle scienze cinese (IVPP) non era riuscito
a estrarne il DNA, ma il Max-Planck-Institut aveva anche
un’altra carta da giocare. Le proteine rappresentano il prodotto finale
dell’espressione dei geni e possono conservarsi più a lungo
di questi, basta pensare al collagene contenuto nelle ossa. Frido
Weilker, quindi, ha preso l’impronta chimica del collagene della
mandibola fossile con una tecnica chiamata ZooMS, scoprendo
forti somiglianze con la falange siberiana. Dunque sì, il fossile donato al Sesto Buddha era davvero un Denisoviano vissuto molto
lontano dalla grotta di Denisova.
.jpg)
Altra immagine ipotetica di Denisoviano
Una conferma della presenza denisoviana a Baishiya è arrivata
anche dal DNA mitocondriale trovato nei sedimenti della grotta.
Questo tipo di DNA presente negli organelli deputati alla produzione
di energia contiene meno informazioni del DNA nucleare
perché è molto più piccolo, ma ha più probabilità di essere conservato
nel corso dei millenni perché è presente in molteplici copie
dentro a ogni cellula. Sembra incredibile, ma un milligrammo di
sedimento può contenerne quasi quanto un milligrammo di osso
antico. Le sequenze rilasciate dagli antichi esseri umani si trovano
mescolate alle molecole originarie di animali, piante e microrganismi
presenti nello stesso posto, ma una volta create «biblioteche di
geni» è possibile separarle. In questo modo, Zhang e colleghi hanno
dimostrato la presenza di DNA denisoviano nella grotta e sperano
di trovare presto altri elementi per ricostruire la storia evolutiva
e lo stile di vita degli abitanti arcaici dell’altopiano.
«Usiamo le tecniche di analisi delle paleoproteine su tutti i
frammenti ossei più grandi di 20 millimetri che vengono alla luce
e cerchiamo il paleoDNA sia nei fossili umani e animali sia nei
sedimenti»,
ci racconta l’archeologa, che spera di riuscire prima
o poi a estrarre anche del DNA nucleare.
«Sono convinto che altri
fossili potranno essere assegnati ai Denisoviani grazie alle analisi molecolari. Il numero crescente di fossili frammentari ma riconoscibili
ci consentirà di capire la distribuzione geografica e temporale
di questo gruppo»,
aggiunge Welker.
Nel luglio 2024 Baishiya ha fornito molte informazioni sulle
prede cacciate da questi antichi uomini. Fra tutte spiccano per
numero le pecore blu dell’Himalaya, ma compaiono anche yak,
cervi, iene, lupi, leopardi delle nevi, aquile reali e fagiani. I segni
sui resti suggeriscono che le carcasse venissero manipolate per ricavarne
tutto il possibile: pelle, carne, midollo e strumenti in osso.
In mezzo a tanti fossili animali è spuntato anche un altro indizio
importante: una costola provvista di proteine denisoviane con
una datazione piuttosto recente. Questo ritrovamento sembra indicare
che la presenza denisoviana nel sito è durata grosso modo
quanto nella grotta di Denisova, all’incirca da 200.000 fino a
40.000 anni fa. Suggerisce anche che questi umani siano vissuti
abbastanza a lungo da avere la possibilità di incontrare i Sapiens
che già abitavano l’altopiano.
Con l’aumentare delle informazioni
genetiche si potrà chiarire quanto è stretta la parentela tra coloro
che vivevano in Siberia (che ora ci appare non più il centro ma l’estrema
periferia occidentale del mondo perduto dei Denisoviani)
e quelli che popolavano la vasta area tra Asia e Oceania, gli stessi
che hanno lasciato tracce nel DNA umano moderno. Inoltre, i fossili
identificati via via come appartenenti al gruppo aiuteranno a
comporre un identikit morfologico con cui confrontare altri potenziali
candidati privi di DNA in buono stato.
«A oggi la mandibola di Xiahe e la costola trovata a Baishiya sono
gli unici fossili ufficialmente accettati come denisoviani oltre
ai micro-frammenti e ai macro-denti scoperti nella grotta di Denisova.
Ma in Cina ci sono altri fossili ufficiosamente considerati come
probabili denisoviani e possono aiutarci a ricostruire l’aspetto
di questo gruppo umano»,
sostiene Condemi, che nel suo ultimo
libro propone il seguente identikit: Denisova = cranio di Harbin +
mandibola di Xiahe + corpo di Jinniushan.
Quella del fossile di Harbin è un’altra vicenda appassionante.
Come raccontano Condemi e Savatier, questo cranio conservato
quasi alla perfezione è passato fortunosamente indenne attraverso
alcune delle stagioni più drammatiche della storia cinese.
Oggi la città della Manciuria da cui prende il nome è conosciuta
per il meraviglioso festival delle sculture di ghiaccio, ma quando il
fossile venne alla luce negli anni trenta del secolo scorso quest’area
faceva parte dello Stato fantoccio creato dal Giappone sul continente
e ospitava un centro di ricerca batteriologica tristemente
noto per gli esperimenti su migliaia di cavie umane.
Quando i muratori che stavano lavorando alla costruzione di
un ponte trovarono il cranio, il caposquadra lo nascose in un pozzo
abbandonato per metterlo al sicuro. Vi restò a lungo, anche una
volta finita l’occupazione giapponese, probabilmente perché non
conveniva a nessuno ammettere di aver collaborato con l’invasore.
Quel nascondiglio lo ha protetto durante e dopo la sanguinosa
Rivoluzione Culturale, fino al 2018, quando il caposquadra in
punto di morte si è deciso a svelare a un nipote l’esistenza del tesoro
segreto. Venuto a conoscenza del ritrovamento, il paleontologo
Qiang Ji è riuscito a portarlo al museo dell’Università di
Hubei, e nel 2022 il fossile di Harbin è diventato famoso con il soprannome
di Uomo Drago. Gli studiosi cinesi gli hanno attribuito 150.000 anni e hanno proposto per lui una nuova specie (Homo
longi), senza però riuscire a convincere la comunità scientifica internazionale.
Il sospetto (ma forse potremmo dire l’auspicio) avanzato
da diversi specialisti, al di fuori della Cina, è che si tratti di un
cranio denisoviano.
Se questa ipotesi è vera, possiamo finalmente
guardare in faccia un esemplare dell’elusivo gruppo umano.
Per quanto riguarda le fattezze del corpo, invece, il fossile
potenzialmente denisoviano più completo è la donna di Jinniushan,
rinvenuta nel 1984 in una grotta non lontano dalla città di
Dashiqiao, nella Provincia del Liaoning. Di lei abbiamo un avambraccio,
alcune vertebre e costole, una rotula, ossa di mani e piedi
e mezzo bacino. Il cranio ridotto in mille pezzi da un colpo di
zappa è stato pazientemente ricomposto, per quanto possibile, dai ricercatori cinesi. Nell’insieme, questa donna presenta somiglianze
con altri «sospetti Denisoviani», di cui sembra una versione
più gracile, forse per via del dimorfismo sessuale, forse perché
potrebbe essere più evoluta (alcune analisi le assegnano un’età di
260.000 anni, ma la sua datazione è incerta come quella di molti
fossili trovati in Cina e altrove).
Secondo Condemi le sue proporzioni
mostrano un adattamento al freddo e ricordano la corporatura
delle neanderthaliane e anche delle donne inuit.
Nel complesso, secondo la studiosa, i dati biogeografici, archeologici
e paleontologici sarebbero ormai abbastanza ricchi da lasciarci
alle spalle l’idea che i Denisoviani siano una popolazione
«fantasma», disincarnata perché arrivata fino a noi soltanto attraverso
i suoi geni.
«Oltre al loro DNA, ormai conosciamo anche la morfologia, attraverso i caratteri ossei e dentali osservati nei fossili
di Denisova, Xiahe, Harbin, Jinniushan e non solo».
La lista si allunga
con i fossili di Xujiayao, Dali, Lingjing, Maba, Penghu e altri
ancora, ma è bene ricordare che a oggi questa definizione paleontologica
non ha ancora i crismi dell’ufficialità.
Un ultimo aiuto arriva dagli studi molecolari che hanno provato
a prevedere l’aspetto fisico degli abitanti di Denisova, a partire
dalla ragazzina vissuta circa 70.000 anni fa nella grotta siberiana,
quella di cui abbiamo trovato la punta del mignolo contenente
un genoma in ottimo stato. Il sequenziamento ha svelato che doveva
avere occhi, capelli e pelle scura, ma altre informazioni utili
possono essere ricavate dall’analisi delle modifiche chimiche apposte
sopra alle lettere del suo DNA. In questo caso si parla di epi-genetica, anziché di genetica.
«Il ritratto che emerge è compatibile
con le caratteristiche mostrate dai fossili denisoviani o presunti
tali. Dobbiamo immaginare esseri umani dall’aspetto arcaico, con
ossa spesse, fianchi larghi, arti possenti, cranio a forma di pallone
da rugby e faccia lunga»,
riassume Condemi.
Il volto della ragazzina-ambasciatrice del popolo di Denisova è
stato presentato nel 2019 da Liran Carmel, pioniere della paleoepigenetica
della Hebrew University di Gerusalemme. Per capire
l’approccio è utile partire dall’esempio del girino e della rana,
che hanno gli stessi geni ma un aspetto decisamente diverso.
Il primo ha branchie e coda, la seconda ha quattro zampe e respira
fuori dall’acqua, perché in corrispondenza di lettere chiave del
genoma presentano una diversa distribuzione dei gruppi chimici
che rendono i geni più o meno accessibili alla trascrizione.
Carmel
e colleghi hanno studiato come questi interruttori molecolari
influenzano l’espressione dei geni umani che determinano la
morfologia scheletrica, mettendo a confronto Denisoviani, Neanderthaliani
e Sapiens. Ne è nato un modello predittivo – ancora
sperimentale – che permette di indovinare le caratteristiche fisiche
sulla base delle mappe di distribuzione dei gruppi metile,
con un livello di accuratezza buono ma ancora non ottimale. I fossili
non assegnati che presentano le caratteristiche denisoviane
così dedotte dovrebbero essere considerati presunti Denisoviani?
«Abbiamo cercato di quantificare la corrispondenza tra antichi
crani ben noti con una tassonomia umana non determinata e
il nostro modello, ma l’articolo deve ancora superare la peer-review,
è presto per parlarne»,
ci risponde Carmel.
La frontiera si sposta sempre più in là, arrivando quasi a sfiorare
la fantascienza. Nell’ultimo lavoro pubblicato, per esempio,
il gruppo prova a prevedere l’espressione del DNA antico in cellule
che non fossilizzano, come i neuroni. Purtroppo non avremo
mai un cervello arcaico da studiare, ma almeno in parte i marcatori
epigenetici vengono apposti così precocemente durante lo
sviluppo da essere comuni ai diversi tipi cellulari. La sfida consiste
nel provare a identificarli nei geni più interessanti dal punto
di vista delle neuroscienze, a partire dal DNA recuperato dalle
ossa. La speranza è che algoritmi come questi, allenati sui dati di
metilazione di uomini arcaici e moderni e di altri primati, riusciranno
ad aprire nuovi scorci sulla crescita cerebrale e altri processi
cruciali per l’evoluzione umana.
di Anna Meldolesi
I Denisoviani
sono una specie? Noi umani moderni ci definiamo Homo sapiens. Se la Commissione
internazionale per la nomenclatura zoologica decidesse che gli
abitanti dei siti di Denisova e Baishiya meritano di essere considerati
come i rappresentanti di una specie a parte, potrebbero chiamarsi
Homo denisovensis o Homo altajensis, dal nome della prima
grotta in cui sono stati scoperti o del massiccio montuoso dove
è situata. Ma visto che ci siamo ripetutamente incrociati con loro, è
opportuno dichiarare che siamo specie diverse? Non sarà il caso di
unire tutti sotto l’ombrello H. sapiens e distinguerci a livello di sottospecie?
Secondo la definizione classica proposta da Ernst Mayr,
una specie biologica è «una popolazione o un gruppo di popolazioni
i cui individui possono effettivamente o potenzialmente riprodursi
tra loro e generare una discendenza vitale e feconda, in condizioni
naturali».
I paleontologi, però, hanno a che fare con creature estinte e sono
soliti usare il concetto di morfospecie, o specie morfologica, per
cui dividono o raggruppano i fossili in base alle somiglianze fisiche
strutturali, trovandosi spesso in disaccordo tra loro. C’è poi il concetto
di «specie genetica», che tiene in considerazione le variazioni
genetiche dentro al gruppo e fra i gruppi per tracciare gli spartiacque.
La materia, insomma, è complicata e scivolosa.
Quando il DNA estratto dal mignolo fossile della ragazza di Denisova
ha rivelato l’esistenza di un gruppo diverso sia da H. sapiens
che dai Neanderthal, Svante Pääbo e i responsabili degli scavi nella
grotta siberiana hanno proposto la dicitura Homo altaiensis
nell’articolo che hanno inviato insieme a «Nature». Ma sono passati
al nome più informale di Denisoviani dopo che un revisore li
ha invitati alla cautela: prima di dichiarare l’esistenza di una nuova
specie sulla base di un singolo genoma, meglio aspettare nuovi dati.
La scuola russa, comunque, ritiene che le informazioni raccolte
siano sufficienti per riconsiderare la questione e propendono per
una distinzione in sottospecie.
In un articolo del 2020 intitolato Who Were the Denisovans?, gli
scienziati russi Anatoli Derevianko, Michael Shunkov e Maxim
Kozlikin propongono per noi la dicitura Homo sapiens africaniensis.
I due principali gruppi umani con cui i nostri antenati di provenienza
africana si sono incrociati, invece, diventerebbero Homo
sapiens neanderthalensis e Homo sapiens altaiensis. Nel dubbio,
per ora, la maggior parte degli studiosi continua a parlare genericamente
di Neanderthaliani e Denisoviani per indicare gli uomini arcaici
che abbiamo assimilato e soppiantato, tanto da poterli definire
estinti anche se i loro geni continuano a vivere dentro di noi.
Il ciondolo e il problema delle datazioni incerte La grotta di Denisova sui Monti Altaj, in Siberia, è eccezionale per la
conservazione del DNA antico, purtroppo però questo sito ha sofferto
disturbi significativi nel corso del tempo, a causa dell’attività delle iene
e di processi periglaciali, che hanno compromesso parzialmente l’integrità
degli strati archeologici. Di conseguenza, secondo una revisione
pubblicata nel 2024 da Francesco d’Errico, del CNRS francese, insieme
ad altri studiosi, molte attribuzioni cronologiche basate sulle associazioni
tra campioni datati e manufatti o resti umani sono meno affidabili
di quanto ci piacerebbe pensare.
Secondo questa analisi critica è probabile che i Denisoviani abbiano
frequentato il sito fino a 50.000 anni fa, e che i Sapiens non siano presenti
a Denisova prima di 42.000 anni fa. In passato alcuni ornamenti
sono stati attributi ai Denisoviani, ma la revisione suggerisce che buona
parte di questi oggetti sia databile tra 35.000 e 25.000 anni fa, un periodo
in cui la misteriosa popolazione non c’era più. In particolare ha destato
scalpore l’estrazione di DNA umano da un canino di cerva usato
come pendaglio. Exploit tecnici come questo evidenziano le difficoltà
che si possono incontrare quando i dati genetici devono essere inquadrati
in contesti problematici, che dovrebbero sollevare dubbi sull’età,
sul quadro culturale e sull’interpretazione degli oggetti. «I genetisti sono
mal consigliati se credono che la loro disciplina un giorno permetterà
di ricostruire la storia umana senza il supporto di dati archeologici
di qualità; allo stesso modo gli archeologi devono evitare la tentazione
di pensare che il loro lavoro finisce con lo scavo di un sito e il trasferimento
dei campioni ai colleghi genetisti», hanno scritto d’Errico e coautori,
auspicando una collaborazione più stretta tra competenze diverse,
che porti a una narrazione davvero multidisciplinare del passato
dell’umanità.
La «plant economy» di Denisova Laura Longo, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
lavora sulle industrie litiche della grotta
di Denisova dal 2018, prima che la pandemia
e la guerra iniziassero a ostacolare le collaborazioni
internazionali. Molti archeologi si concentrano
sugli strumenti usati per cacciare
le prede, lei invece si interessa soprattutto
ai ciottoli impiegati per lavorare le piante. In
particolare dallo strato 11, datato fra 50.000 e
35.000 anni fa, sono emersi resti di Denisoviani
e dal DNA sedimentario sappiamo che era
presente anche H. sapiens. Insieme ai colleghi
russi, Longo ha campionato pietre caratterizzate
da una forma compatibile con l’attività di
macinazione di vegetali selvatici, cercando di
discriminare tra i diversi usi.
Le piante non si conservano facilmente e per
questo tipo di studi è necessario ricorrere a
tecniche sofisticate (approcci avanzati di microscopia
e determinazione chimica, anche
con la luce di sincrotrone). Rizomi, tuberi, frutti
e semi sono ricchi di amido, ma le piante possono
fornire anche fibre e legno per fabbricare
corde, reti e contenitori, utili per trasportare gli
oggetti durante gli spostamenti, che erano frequenti.
«I ciottoli di Denisova presentano tracce
di amido per scopi alimentari ma anche di
altre lavorazioni». Chi li usava?
«Per rispondere in modo definitivo bisognerebbe
esaminare un maggior numero di campioni
e servirebbero altri dati di analisi stratigrafica»,
ci dice Longo. I Denisoviani facevano abbondante
uso di risorse vegetali ma è probabile che
non fossero mangiatori abituali di amido, diversamente
da noi che lo digeriamo in modo più
efficiente. I geni necessari per metabolizzaepire
questo composto sono aumentati di numero
in Homo sapiens, presumibilmente perché l’invenzione
dell’agricoltura ha favorito gli individui
meglio equipaggiati da questo punto di vista.
Recentemente uno studio statunitense, in collaborazione
con lo Human Technopole di Milano,
è arrivato a questa conclusione confrontando
il DNA di umani viventi e antichi. Denisoviani
e neanderthaliani non hanno più di due copie di
questi geni, secondo le analisi del progetto Starch4Sapiens,
che vede Longo collaborare con
Alessandra Carbone e Silvana Condemi, rispettivamente
del CNRS di Parigi e Marsiglia (nella
foto a fianco reperti rinvenuti a Denisova).
Eugenio Caruso - 10 febbraio 2025

Tratto da le scienze